Come il femminismo divenne ancella del capitalismo – e come riscattarlo
di Nancy Fraser
Un movimento che è nato come una critica dello sfruttamento capitalista ha finito per apportare idee chiave alla sua ultima fase neoliberista.
Come femminista, ho sempre pensato che, combattendo per l’emancipazione delle donne, stavo costruendo un mondo migliore – più egualitario, giusto e libero. Ma ultimamente ho cominciato a preoccuparmi che gli ideali difesi dalle femministe stiano servendo fini molto diversi. Mi preoccupa, in particolare, che la nostra critica del sessismo stia ora fornendo la giustificazione di nuove forme di disuguaglianza e sfruttamento.
Per un crudele scherzo del destino, ho paura che il movimento per la liberazione delle donne si sia avvitato in una relazione pericolosa con le spinte neoliberiste a costruire una società di libero mercato. Questo spiegherebbe come sia accaduto che le idee femministe, un tempo parte di una visione del mondo radicale, siano sempre più espresse in termini individualistici. Mentre una volta le femministe criticavano una società che promuoveva il carrierismo, ora consigliano alle donne di “darci dentro”. Un movimento che una volta promuoveva la solidarietà sociale, ora celebra le donne imprenditrici. Una prospettiva che una volta valorizzava la cura e l’interdipendenza, ora incoraggia il successo individuale e la meritocrazia.
Quello che si cela dietro questa metamorfosi è un cambiamento di rotta nel carattere del capitalismo. Il capitalismo organizzato di Stato del dopoguerra ha lasciato il posto a una nuova forma di capitalismo – “disorganizzato”, globale, neoliberista. Il femminismo di seconda ondata è emerso come una critica del primo, ma è diventato l’ancella del secondo.
Con il senno di poi, possiamo ora vedere che il movimento per la liberazione delle donne indicava contemporaneamente due futuri possibili. In un primo scenario, esso prefigurava un mondo in cui l’emancipazione di genere andasse di pari passo con la democrazia partecipativa e la solidarietà sociale; in un secondo, prometteva una nuova forma di liberalismo, in grado di garantire alle donne così come agli uomini i privilegi dell’autonomia individuale, maggiore scelta, e l’avanzamento meritocratico. Il femminismo di seconda ondata è stato in questo senso ambivalente. Compatibile con una delle due diverse visioni della società, era suscettibile di due diverse elaborazioni storiche.
Per come la vedo io, l’ambivalenza del femminismo si è risolta in questi ultimi anni a favore del secondo scenario liberal-individualista, ma non perché siamo state vittime passive delle seduzioni neoliberiste. Al contrario, abbiamo noi stesse concorso a questo sviluppo con tre importanti idee.
Ha contribuito la nostra critica del “salario familiare”: l’ideale di famiglia del maschio che porta a casa il pane e della femmina massaia era centrale per il capitalismo organizzato di Stato. La critica femminista di quell’ideale serve ora a legittimare il “capitalismo flessibile”. Dopotutto, questa forma di capitalismo si sostiene pesantemente sul lavoro femminile salariato, soprattutto quello a basso costo nell’industria e nei servizi, svolto non solo da giovani donne single, ma anche da donne sposate e donne con figli piccoli; non solo da donne di colore, ma da donne di qualsiasi nazionalità ed etnia. Appena le donne si sono riversate nei mercati del lavoro di tutto il mondo, l’ideale del salario familiare tipico del capitalismo organizzato di Stato è stato sostituito dal nuovo, più moderno ideale della famiglia a due stipendi (apparentemente sanzionato dal femminismo).
Non importa che la realtà che sta alla base del nuovo ideale consista in livelli salariali depressi, ridotta sicurezza del lavoro, peggioramento della qualità della vita, pesante aumento del numero di ore lavorative, esacerbazione del doppio turno – oggi spesso triplo o quadruplo – e aumento della povertà, sempre più concentrata in donne capofamiglia. Il neoliberismo trasforma l’orecchio di una scrofa in una borsa di seta elaborando una narrazione dell’autoaffermazione femminile. Invocando la critica femminista del salario familiare per giustificare lo sfruttamento, esso incanala il sogno dell’emancipazione femminile nel meccanismo di accumulazione del capitale.
Il femminismo ha dato anche un secondo contributo all’ethos neoliberale. Nell’era del capitalismo organizzato di Stato, abbiamo giustamente criticato una visione politica ristretta, così intensamente focalizzata sulla disuguaglianza di classe da non essere in grado di vedere quelle ingiustizie “non economiche” come la violenza domestica, la violenza sessuale e l’oppressione riproduttiva. Rifiutando l'”economicismo” e politicizzando “il personale”, le femministe hanno ampliato l’agenda politica fino a sfidare le gerarchie di status fondate sui costrutti culturali della differenza di genere. Il risultato avrebbe dovuto essere di espandere la lotta per la giustizia fino a comprendere sia la cultura che l’economia. Ma il risultato effettivo è stato un fuoco unilaterale sull'”identità di genere”, a scapito delle questioni di fondo. Peggio ancora, lo scivolamento femminista nelle politiche identitarie si è incastrato fin troppo bene con un neoliberismo in ascesa che non desiderava altro che cancellare ogni ricordo di eguaglianza sociale. In effetti, abbiamo assolutizzato la critica del sessismo culturale proprio nel momento in cui le circostanze avrebbero richiesto un’attenzione raddoppiata alla critica dell’economia politica.
Infine, il femminismo ha apportato una terza idea al neoliberismo: la critica al paternalismo dello Stato sociale. Innegabilmente progressista nell’epoca del capitalismo organizzato di Stato, questa critica ha intersecato la guerra del neoliberismo allo “Stato balia” e la sua più recente inclusione cinica delle ONG. Un esempio significativo è quello del “microcredito”, il programma di piccoli prestiti bancari alle donne povere nel sud del mondo. Lanciato come un’alternativa di empowerment “dal basso”, rimedio contro la burocrazia dei progetti statali, il microcredito è propagandato come l’antidoto femminista alla povertà e alla sottomissione delle donne. Ciò che è stata omessa, tuttavia, è una coincidenza inquietante: il microcredito è fiorito proprio nel momento in cui gli stati hanno abbandonato gli sforzi macro-strutturali per combattere la povertà, sforzi che i prestiti di piccola scala non possono assolutamente sostituire. In questo caso, quindi, un’idea femminista è stata riciclata dal neoliberismo. Una prospettiva finalizzata originariamente a democratizzare il potere dello Stato al fine di responsabilizzare i cittadini è ora utilizzata per legittimare la mercificazione e i tagli alla spesa pubblica.
In tutti questi casi, l’ambivalenza del femminismo si è risolta a favore del (neo)individualismo liberale. Ma l’altro scenario, solidale, potrebbe ancora essere realizzabile. La crisi attuale offre la possibilità di riacciuffare il suo filo, riconnettendo il sogno di liberazione delle donne con la visione di una società solidale. A tale proposito, le femministe hanno bisogno di rompere la nostra relazione pericolosa con il neoliberismo e recuperare i nostri tre “contributi” per i nostri fini.
In primo luogo, potremmo rompere il legame spurio tra la nostra critica del salario familiare e il capitalismo flessibile militando per una forma di vita che de-centri il lavoro salariato e valorizzi le attività non salariate, tra la quali – ma non solo – la cura. In secondo luogo, potremmo impedire lo scivolamento della nostra critica all’economicismo nelle politiche identitarie integrando la lotta per trasformare un ordine fondato su valori culturali maschilisti con la lotta per la giustizia economica. Infine, potremmo recidere il falso legame tra la nostra critica della burocrazia e il fondamentalismo del libero mercato ricucendo il tessuto della democrazia partecipativa come un mezzo per rafforzare i poteri pubblici necessari a vincolare il capitale in favore della giustizia.
(Fonte: http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/14/feminism-capitalist-handmaiden-neoliberal. Traduzione di Serena Contardi)




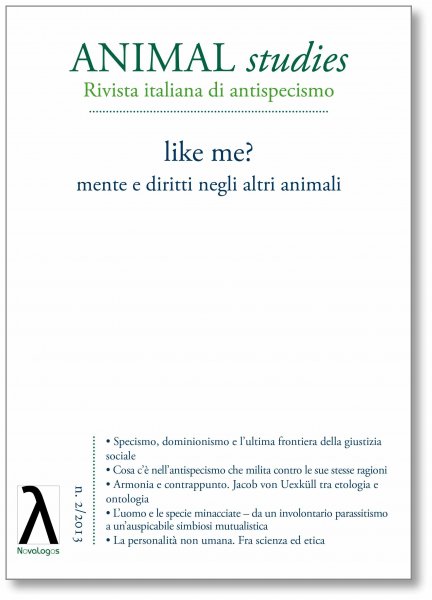
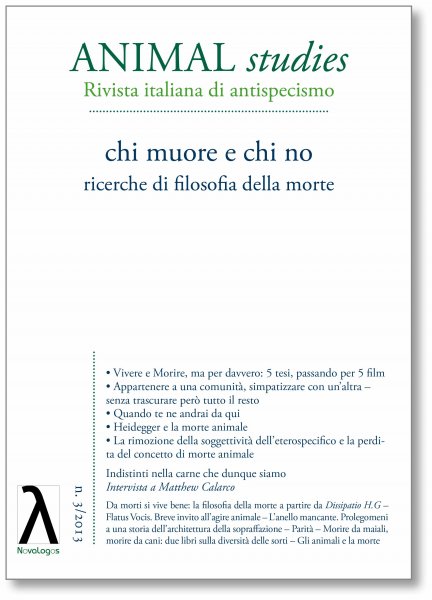
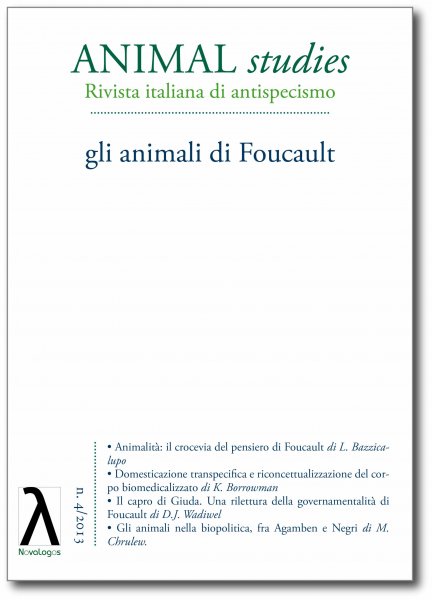


non posso fare a meno di citare una mia amica:
‘non metto in dubbio che sia interessante, quantomeno come esempio di (auto)critica, seppur non dichiarata, che va certamente salutata con soddisfazione. rimangono però molte problematicità. la prima, fondamentale, tipica del femminismo mainstream statunitense, è che appunto si tende a far collassare i femminismi sul “femminismo” istituzionale, quello imperante negli uffici del genere delle organizzazioni sovranazionali (per citare il manifesto transfemminista). il che produce una critica parziale non situata che genera confusione e un’ulteriore strumentalizzazione dei femminismi al fine di sostenere le proprie tesi, nascondendo (consapevolmente?) tutto ciò che non è mai stato mainstream. insomma, un discorso che poggia sulla fallacia della reductio ad unum (altrove fa la stessa operazione sul queer). del resto, la critica di Fraser, a tratti superficiale, ai processi di sussunzione neoliberale del femminismo può valere per tutte le forme teorico-pratico-politiche, anche rivoluzionarie, del novecento (vedi la critica alla critica del paternalismo del welfare state). che cosa si risponderebbe a qualcuno che per criticare il postoperaismo dicesse che il rifiuto del lavoro ha prodotto la precarietà selvaggia? detto questo, parliamone pure.’
p.s. l’articolo sul queer è questo: http://www.lavoroculturale.org/quale-futuro-per-il-soggetto-queer/
Preceduta da frantic, non posso che condividere le sue stesse opinioni. A partire dal fatto che il ‘Femminismo’ con la effe maiuscola non esiste, ma esistono femminismi declinati in mille maniere. Il problema di un analisi del genere è che, in definitiva, nel non considerare quei femminismi ‘grassroots’ tanto diversi ma in dialogo tra loro, fertilissimi di idee, contaminazioni, esperienze (poi nemmeno tanto micro nei numeri a ben vedere, ma solo a volte nella visibilità mainstream), legittima nella sostanza il ‘pensiero unico femminista’… Un pò a la SNOQ (o Paestum) per rimanere in terra italica, che vorrebbero appiattire la varietà e molteplicità femministe in una sola, certificata, che non ci appartiene per niente.
Ps: Dimenticavo, sono convinta che questa ‘dimenticanza’ risponda ad una preciso disegno politico che mira al ‘cambiare tutto per non cambiare niente’. Gli strumenti, le esperienze, le opportunità alternative esistono, basta agitare un pò i neuroni e non soffermarsi solo in superficie per scoprirle…sempre che se ne abbia la voglia!
sono d’accordo con voi, però ritengo che questo articolo andasse tradotto (e ringrazio chi l’ha fatto) perché in Italia una critica al femminismo liberale non esiste o, meglio, non raggiunge la soglia della visibilità. Ed è proprio la mancanza di una critica forte delle implicazioni tra femminismo liberale e capitalismo che permette quella reductio ad unum di cui si nutre il pensiero unico di fenomeni mainstream come snoq. Dalla lettura dell’articolo, non mi pare di poter ricavare che Fraser spinga in questa direzione, cioè che a sua volta voglia legittimare l’esistenza di un Femminismo per eccellenza. Che ci vogliamo fare, è un’accademica, non una militante di movimento.
Rubo alla Lipperini – spero non a sproposito – questa citazione, che mi è tornata in mente quando ho letto la chiusa del tuo commento, Pantafika…”Focault in Microfisica del potere scrive: “Quel che gli intellettuali hanno scoperto a partire dalle esperienze politiche degli ultimi anni è che le masse non hanno bisogno di loro per sapere; sanno perfettamente, chiaramente, molto meglio di loro, e lo dicono bene. Ma esiste un sistema di potere che blocca, vieta, invalida questo discorso e questo sapere; potere che non è solo nelle istanze superiori della censura, ma che affonda molto in profondità, e molto sottilmente in tutte le maglie della società. Gli intellettuali stessi fanno parte di questo sistema di potere, l’idea che essi siano gli agenti della ‘coscienza’ e del discorso è parte di questo sistema. Il ruolo dell’intellettuale non è più di porsi ‘un po’ avanti o un po’ a lato’ per dire la verità muta di tutti; è piuttosto di lottare contro le forme di potere là dove ne è ad un tempo l’oggetto e lo strumento: nell’ordine del ’sapere’, della ‘verità’, della ‘coscienza’ e del ‘discorso’. E’ in questo senso che la teoria non sarà l’espressione, la traduzione o l’applicazione di una pratica, ma una pratica essa stessa”.
Hai detto bene, in Italia la critica al femminismo liberale, che esiste, NON RAGGIUNGE LA SOGLIA DELLA VISIBILITA’. Non sono perciò contenta se l’intellettuale (o pseudo) di turno possiede il POTERE di ratificare le nostre esperienze e critiche al sistema (ma poi in che modo? Spesso parziale, spesso contradditorio, spesso ‘edulcorato’) e sia l’unic* a cui è concesso di renderle PRONUNCIABILI E PENSABILI. E non perchè si voglia apporre il proprio ‘marchio di fabbrica’ sul pensiero, ma perché, perlomeno per come la vedo io, oltre ad essere spesso una lettura come ho già detto parziale, si inscrive in quel meccanismo che toglie la voce e svuota i contenuti delle persone che li attuano (o ci provano) e lottano per essi. E’ positivo che si parli di certe cose, ma COME se ne parla? E se le dinamiche di potere e di privilegio non cambiano, tutte queste parole che significato hanno?
Sono interamente d’accordo con l’ultimo commento di lapantafika. L’articolo ha i limiti evidenziati sopra, e’ assolutamente vero, ma bisogna anche tener conto del fatto che il fatto che Nancy Fraser stia prendendo una posizione netta sulla necessita’ di riconnettere politica di genere e politica di classe e’ un grosso passo in avanti. Diciamo che, con tutti i limiti, almeno ha la possibilita’ di parlare a un pubblico molto ma molto piu’ ampio di quello a cui parlano le femministe che in questi anni hanno continuato a parlare di questioni di classe, venendo spesso ignorate.
conosco quel passo e mi pare proprio che ad oggi la tecnologia abbia reso possibile un passo avanti rispetto agli anni in cui scriveva Foucault. L’università ha perso se non completamente, almeno per buona parte il ruolo egemone di produzione del sapere, anche perché gli accademici e le accademiche vivono spesso uno scollamento rispetto alla realtà che analizzano e credo sia questo il caso della Fraser, di cui apprezzo la critica al neoliberismo, senza però dimenticare che il prezzo che pago io alle politiche neoliberiste non è quello che paga lei (e qui c’entra la classe). L’intellettuale non detiene più il potere esclusivo di ratificare le nostre esperienze e non è più l’unico/a a cui è concesso di renderle pronunciabili e pensabili. Se così non fosse, io e te non potremmo nemmeno star qui a parlarne, come non ci potevamo stare 20 anni fa. Detto questo, ti ripeto, sono pienamente d’accordo con i limiti che tu e frantic evidenziate, però in Italia di un articolo come quello c’è bisogno, anche per dar luogo ad un dibattito che ne evidenzi le criticità e che così dia modo di portare in supericie il lavoro militante che in tante/i facciamo, a gratisse e con poca o nulla visibilità e dunque efficacia.
Ma io mica sono ‘contraria’ alla traduzione e condivisione dell’articolo…tutto il contrario! Ti faccio però notare che la tecnologia e il fatto che io e te ‘stiamo qui a parlarne’ non significa assolutamente che quello che diciamo sia pronunciabile e pensabile ad un livello pubblico che abbia una visibilità al di fuori di determinati contesti. Il rischio, non solo teorico ma anche pratico e che ho visto agito più e più volte negli ultimi anni -, è quello di vedere un certo femminismo appropriarsi di istanze e esperienze originali e uniche, ridurle ad un involucro vuoto e liofilizzato pronto ad essere ‘digerito’ da chiunque e perciò svuotato della sua carica sovversiva. In questo senso, il fatto che stiamo qui a parlare di determinate cose è molto utile a chi non vuole faticare a trovare parole nuove, che semplicemente si appropria di quello che intuisce avere un significato politico – e fin qui non c’è nulla di male, se si è per la condivisione di pratiche e saperi – ma lo trasforma il più delle volte in un simulacro innocuo e anzi spesso in collusione al sistema come sottolinea la traduzione. In ogni caso, reputo utile questo scambio di idee proprio a problematizzare un articolo che trovavo monco in alcune sue parti, ma grazie ad Asinus di averlo condiviso!
più che per noi quell’articolo serve per le femministe liberali e a loro è rivolto
il femminismo mainstream si appropria di istanze che provengono dalla cooperazione sociale, le fagocita e le svuota della portata r-evoluzionaria (quello che adesso sta succedendo dopo Paestum). Verissimo. Così funzionano i dispositivi di cattura del capitale. I conti a me tornano, purtroppo.
e comunque per il queer vale la stessa identica storia del femminismo. Guarda sta roba
http://marimachobk.com/about/
Il queer non è immune dai dispositivi di cattura del capitale, o abbiamo in mente come funzionano quelli e ci sottriaiamo o ciccia. Io ultimamente mi sono trovata in situazioni da vomito nella totale inconsapevolezza dei/delle sedicenti queers, che si rivendicavano pure la palma di rivoluzionari.
Scusate ma che sarebbe il femminismo mainstream? Irigary, Cixous, Kristeva, Haraway, Butler, Cavarero, per fare degli esempi, sarebbero, e quali di queste, mainstream. oppure no? E Adams?
Scusate, ma non so che ne pensate, quindi chiedo. Il sospetto mi viene da quella che avverto, magari sbagliando, come schizzinosità verso gli intellettuali.
Non che non condivida la posizione di Foucault, ma Foucault stesso era a suo modo un “intellettuale”, sebbene divergente e “sovversivo” nel metodo e nell’approccio al/ai saperi in quanto “pensatore”.
Nella sua “vita pubblica” ha, p es, discusso riforme del sistema penale che, benché poggiando su una sovversione dei paradigmi presenti, erano tutt’altro che “rivoluzionari”. D’altra parte la radicalità della sua analisi del potere tendeva ad escludere la possibilità di liberarsi collettivamente dal potere stesso (neppure le sua analisi sulla parresia e sulla filosofia come forma-di-vita cinica sembrano affatto aprire in questa direzione), tantomeno in termini “rivoluzionari”.
Quindi che tipo di “intellettuale” pubblico (banalizzando in termini di “engagé”) era Foucault?
Possedeva ed esercitava POTERE sull’esperienza dei singoli?
In questo senso, pur essendo un discorso che molte delle pensatrici citate sopra condividerebbero, mi insospettisce (in senso filosofico e politico) questo passaggio:
“Non sono perciò contenta se l’intellettuale (o pseudo) di turno possiede il POTERE di ratificare le nostre esperienze e critiche al sistema (ma poi in che modo? Spesso parziale, spesso contradditorio, spesso ‘edulcorato’) e sia l’unic* a cui è concesso di renderle PRONUNCIABILI E PENSABILI. E non perchè si voglia apporre il proprio ‘marchio di fabbrica’ sul pensiero, ma perché, perlomeno per come la vedo io, oltre ad essere spesso una lettura come ho già detto parziale, si inscrive in quel meccanismo che toglie la voce e svuota i contenuti delle persone che li attuano (o ci provano) e lottano per essi. E’ positivo che si parli di certe cose, ma COME se ne parla? E se le dinamiche di potere e di privilegio non cambiano, tutte queste parole che significato hanno?”.
Gli intellettuali, o i pensatori, di turno, hanno diritto di parlare? Meglio, con o senza diritto, quando parlano esercitano un potere, e un potere di sussunzione che tradisce l’esperienza singolare plurale (cioè l’esperienza delle relazioni)?
Mi viene anche da chiedere come sta la questione dell'”Esperienza” rispetto alle note critiche di Butler (la pretesa di immediatezza dell’esperienza vissuta come “autentica”, la sua presunta prediscorsività, l’assenza di una griglia storico-genealogica che interroghi anche i discorsi, il riprodurre ideologie di genere invece di decostruirle tenendo ferma la dicotomia maschile-femminile ecc…).
In questo cosa fa Butler? L’intellettuale riduzionista che esercita un potere verticale sulla varietà infinta delle – appunto – esperienze? Prende parola per tutt*, arrogandosi una legittimità che la pluralità dei singoli non le ha mai concesso, “consegnato”?
Dove e come si traccia la linea di confine, dunque, fra chi “condivide” e chi *esercita* il potere?
Sono molto curioso di come la pensate.
non nutro nessuna avversione verso gli intellettuali, sinceramente.
però ti faccio notare ad esempio che tutte le femministe citate da te sono bianche; e bell hooks, angela davis, patricia hill collins, gayatri spivak e gloria anzaldúa [per citarne qualcuna] fanno riferimento a femminismi altri che non mi pare proprio siano in sorellanza col capitale; anzi, da esso hanno sempre subìto, proprio perché il femminismo bianco si è totalmente slegato da istanze di classe trovando nel parziale riconoscimento istituzionale di sé la chiave di volta per potersi legittimare, per l’appunto, a livello mainstream.
insomma, la critica rispetto al testo di cui sopra non consiste nel non voler ammettere che il femminismo è divenuto ancella del capitalismo, ma bensì nel voler aggiungere che non si tratta del femminismo tout court, ma da alcuni segmenti di esso, il che è piuttosto diverso.
sarebbe come se, criticando l’antispecismo debole, parlassi semplicemente di antispecismo, ignorando però che nel termine antispecismo è contenuto anche l’antispecismo politico che è cosa diversa e al quale non si possono certo affibbiare le stesse posizioni dell’ antispecismo debole. motivo per cui è molto facile interpretare la reductio ad unum dell’articolo come un tentativo di screditare tutti i femminismi in generale attraverso la critica male esplicitata del percorso del femminismo bianco.
“Gli intellettuali, o i pensatori, di turno, hanno diritto di parlare?” Certo che sì, ma prendendosi la responsabilità delle proprie parole (dato che purtroppo in una società verticale le loro parole hanno un certo peso) , e tenendo comunque conto di avere un approccio situato e per molti versi privilegiato, in nessun modo ‘super partes’. Perché, ed è quello che più non mi piace di questo articolo oltre agli aspetti che ho già evidenziato prima, è anche il fatto di continuare a focalizzarsi su uno solo degli aspetti del femminismo,declinandolo come il Femminismo – o comunque come una parte rilevante di esso – a renderlo così potente e ‘importante’ e ad invisibilizzare tutti gli altri. Questo aspetto non si può ignorare! Dare voce, spazio e agibilità politica ai femminismi altri, questa è per me la vera critica a certo femminismo.
Ciao Derridilgambo, dalla tua domanda è nata una risposta sotto forma di post: http://intersezioni.noblogs.org/post/2013/10/23/nancy-fraser-you-lose/
L’effetto domino dell’articolo della Fraser: http://criticallegalthinking.com/2013/10/21/white-feminist-fatigue-syndrome/
Ciao Eg, se visiti il link che ho lasciato prima del tuo commento trovi il collegamento alla traduzione fatta da pantafika di incroci de-generi dell’articolo che hai linkato… a chi interessasse leggerlo in italiano! Ciao f.
Che bellissima discussione! Mi sollevate il cuore. L’articolo di Fraser è interessante, come dice Giorgia, ma secondo me Fraser e molte altre purtroppo non hanno ben capito, riflettuto e interiorizzato un fatto che anche io non avevo colto nei miei primi dieci anni di mio femminismo “comunista”, e ho capito solo dopo la lettura del Contratto sociale di Pateman. Il fatto è: le condizioni materiali e istituzionali della libertà femminile sono state create dal capitalismo di mercato, e solo da esso. Nei modi di produzione precapitalisti e ancor di più nei modelli statalisti le donne sono assolutamente meno ricche, meno empowered e meno libere che in un capitalismo di mercato condito con un ragionevole welfare state. Non lo sapevamo quando abbiamo iniziato, ma ora, almeno io, lo credo. L’orizzonte non è la fine del capitalismo e la fine del potere, di tutti i poteri. L’orizzonte è un capitalismo temperato e una onesta democrazia. Magari cela dessero!