L’antispecismo non esiste. Storia critica di un movimento fantasma
di Marco Maurizi
Estremismo vs. radicalismo
Il titolo di questo testo non è una “provocazione” e non vuole scioccare nessuno: è una mera constatazione che cercherò di argomentare. Non mi sono mai piaciute le tesi “estreme”. È vero che per vedere bene, alle volte, occorre vedere in bianco e nero. Ma è altrettanto vero che se non si è capaci di cogliere le sfumature si è semplicemente stupidi.
Metto le mani avanti, perché ciò che chiamiamo “antispecismo” (e che spesso, con ingiustificato puntiglio, teniamo a distinguere dall’“animalismo”), è un campo assai florido per i sostenitori di tesi “estreme”. E ho detto “estreme”, non “radicali”. Se, infatti, essere radicali, diceva qualcuno, vuol dire “cogliere le cose alla radice” – e dunque andare al fondo dei problemi – essere “estremo” significa vedere solo l’aspetto di superficie di un fenomeno: ovvero essere unilaterali, non comprendere o non saper vedere le sfumature, le tensioni, le contraddizioni di ciò che viene pensato. Vorrei quindi argomentare l’inesistenza dell’antispecismo andando alle sue radici, senza farmi ingannare dall’aspetto superficiale (ovvero che tanti attivisti parlano costantemente dell’antispecismo come di una teoria e di una prassi in cui credono e che praticano).
Le domande da cui muove questo testo, credo, sono domande che qualsiasi attivista con un minimo di spirito critico si sarà fatto almeno una volta:
– perché non c’è alcun accordo sulle tesi fondamentali che dovrebbero tenere insieme un movimento: ovvero cos’è lo specismo e come dovrebbe essere combattuto?
– perché la capacità di discutere e dialogare razionalmente le premesse teoriche e le conseguenze pratiche della lotta allo specismo è così poco diffusa?
– perché nel sedicente “movimento” antispecista qualsiasi tesi, per quanto strampalata, estremista e politicamente suicida, trova terreno fertile?
– perché il livello di organizzazione del “movimento” antispecista è così scarso?
– perché la litigiosità interna è così esasperata tanto da rendere impossibile non solo ogni ipotesi di coordinamento ad ampio raggio ma addirittura di pura e semplice solidarietà tra i diversi gruppi?
– perché non c’è alcuna chiarezza su quali debbano essere gli obiettivi tattici e strategici di questo sedicente movimento?
– infine: perché si continuano a proporre le stesse pratiche fallimentari da oltre trent’anni e, a fronte di uno scoraggiamento quasi unanime sulle speranze di cambiamento a medio e lungo termine, non si determina una riflessione seria e approfondita su di esse[1]?
Non dico che in questo testo sia riuscito a rispondere a tutte queste domande ma credo che ne emerga un quadro genealogico del “movimento” antispecista che possa fornire qualche elemento di chiarezza.
È ovvio che, così dicendo, mi auguro che l’antispecismo esista prima o poi come un insieme coerente di teorie e pratiche in grado di comprendere e smantellare lo specismo. Ma la soluzione, come ho argomentato altrove, è che ci si decida a comprendere cosa sia effettivamente lo specismo. E per me, lo si sa, la strada da seguire è una sola: si superi l’idea secondo cui lo specismo sarebbe un mero pregiudizio morale e lo si comprenda piuttosto come fenomeno socio-storico[2]. Finché lo specismo sarà un’idea vaga anche la lotta contro di esso non potrà che essere confusa ed inefficace. Ritengo infatti, come mostrerò, che l’inconsistenza teorica e pratica dell’antispecismo derivi proprio da questa insufficiente elaborazione teorica.
Un’ultima precisazione: in quanto segue giudico severamente il veganismo, l’abolizionismo e il liberazionismo, nonché tutte le attività che costituiscono la pratica quotidiana degli attivisti antispecisti. Anche qui, non mi interessa affatto la polemica o la provocazione fine a se stessa, ma come non mi sforzo di rendere “simpatiche” le mie tesi, così non mi interessa se ciò che scrivo risulta fastidioso. Mi interessa solo se le mie analisi sono vere o, in caso contrario, quali contro-tesi possano migliorarle o superarle; e per questo è necessario essere chiari e scrivere senza ambiguità o reticenze.
Fatte queste doverose premesse vediamo in che senso e perché l’antispecismo non esiste e perché non esiste né in senso teorico né in senso pratico.
Dispute intellettuali?
Alcuni potrebbero sostenere che l’antispecismo teorico esiste eccome tanto che alcuni, tra cui il sottoscritto, hanno anche cercato negli ultimi anni di differenziare la propria visione dell’antispecismo da quella “classica”[3]. Costoro, certi dell’esistenza di questo antispecismo “classico” ormai ampiamente diffuso tra i militanti, potrebbero essere tentati di definire cavillose o pretestuose o comunque poco utili le pretese di chi vuole proporre nuove vie alla riflessione antispecista. Ma esiste una teoria antispecista classica o “ortodossa”? Esiste un corpus teorico degno di questo nome che io e altri pensatori-che-non-hanno-niente-di-meglio-da-fare si divertirebbero a criticare per egocentrismo o per fare mere discussioni accademiche? No, non esiste. Vediamo perché.
L’inesistenza dell’antispecismo teorico
Cominciamo con un po’ di storia. Il termine “specismo”, come ognun sa, è stato coniato da Ryder nel 1970 e diffuso da Peter Singer in Animal Liberation nel 1975 (due filosofi “puri”, tra l’altro, sia detto per difesa di questa bistrattata categoria…). Dunque è illogico pensare che il movimento antispecista esistesse prima di questa data. C’era, questo sì, un insieme di gruppi che facevano della “difesa” degli animali il proprio scopo, ma poiché la “difesa” degli animali è un concetto assai vago (che, secondo alcuni, includerebbe addirittura gli allevatori “umanitari” e persino i cacciatori che “proteggono” le riserve naturali!) non si può certo dire che esistesse un “movimento” e men che meno un “movimento antispecista”. Cosa esisteva, dunque? Esistevano, grosso modo, i vegetariani, gli zoofili e i protezionisti.
Quando Peter Singer pubblica Liberazione animale, dunque, i suoi lettori non accademici, cioè gli “attivisti” che in un modo o nell’altro si interessano al benessere degli animali, rientrano tra queste tre categorie. Quale grande novità trovano in questo libro che farà epoca? Una definizione di “specismo” e di “antispecismo”? No. Come ho sottolineato altrove[4], “specista” in base alla teoria singeriana è l’attributo di proposizioni morali non un comportamento: esso indica, cioè, la giustificazione morale dello sfruttamento non lo sfruttamento stesso, secondo l’uso che è invece oggi in voga tra gli attivisti[5]. Chi legge il libro di Singer si renderà presto conto che il termine viene usato solo di passaggio nell’argomentazione per indicare un errore nel ragionamento morale. Singer, coerentemente, non usa affatto il termine “antispecismo”. In effetti, il contenuto teorico vero del libro di Singer è l’importanza posta sulla vita degli animali come individui senzienti che nella sua filosofia utilitaristica entrano nel calcolo collettivo della felicità sociale a prescindere dalla specie di appartenenza. In secondo luogo, colpì nel libro di Singer il fatto che una teoria morale accademica giungesse a fornire dignità filosofica (cioè razionale) al vegetarismo, fino ad allora considerato una scelta dovuta alla sensibilità e alla compassione individuali.
Il motivo per cui Singer divenne ben presto la bibbia dei vari gruppi animalisti fu precisamente questo. A gioirne e ad approfittarne furono soprattutto i vegetariani. Questo significa che l’antispecismo di Singer divenne la prima base teorica del movimento antispecista? Niente affatto. Anzitutto perché la filosofia di Singer non si fonda sull’“antispecismo” bensì sull’utilitarismo (l’antispecismo singeriano, ammesso che esista come “visione del mondo”, è una conseguenza dell’utilitarismo). Forse che i vegetariani si convertirono in massa all’utilitarismo che così divenne il fondamento teorico dell’antispecismo? Nemmeno per sogno. Ciò che accadde fu che alcune argomentazioni di Singer, quelle ritenute più “utili”, vennero assunte dai vari gruppi vegetariani e zoofili. Nessuno, o pochi, ne accettarono tutte le conseguenze teoriche, ad es. la desacralizzazione della vita umana che in Singer va di pari passo con la rilevanza morale attribuita agli animali non-umani (quanti animalisti sono inorriditi nel sentire Singer parlare della liceità morale di sopprimere i neonati?). Né, tantomeno, il fatto che in Singer l’obbligo morale del vegetarismo come pratica di vita sia di natura indiretta, cioè che attraverso il non-consumo di carne si possa giungere ad una “massa critica” in grado di mettere in crisi l’industria della carne (in Singer, in altri termini, non esiste alcun divieto morale assoluto del mangiare carne).
Ecco come si spiega il sorgere dell’astro di Tom Regan nel panorama animalista. Tale ascesa fu dovuta al fatto che il pensiero di Regan offriva una risposta a queste esigenze sentite dagli animalisti insoddisfatti di alcune conseguenze del pensiero singeriano. Ed ecco la risposta che fa felici i vegetariani: gli animali vanno salvati in quanto portatori di “diritti” intrinseci, “naturali” e quindi mangiar carne è moralmente sbagliato in sé, non per effetto di un calcolo di utilità generale. Finalmente un filosofo che la dice tutta per bene, pensa il vegetariano, questo sì che è parlar chiaro! Tuttavia, anche nel pensiero di Regan non c’è una “filosofia antispecista” se con quest’espressione si intende una teoria generale che spieghi cosa sia e coma vada combattuto lo specismo (e anche Regan, come Singer, non parla mai di “antispecismo”). Quella di Regan, come quella di Singer, è al massimo una filosofia che ha delle caratteristiche antispeciste, cioè che in alcuni suoi punti denuncia lo specismo…ma sempre all’interno di un ragionamento che poggia su altre basi: il pensiero reganiano è stato, infatti, descritto variamente come una forma di giusnaturalismo (teoria dei “diritti naturali”) o una forma di kantismo morale “allargato”.
Nonostante ciò, negli anni ’80 si inizia a parlare di “antispecismo” come di una filosofia complessiva di cui Singer e Regan sarebbero i grandi teorici (seppure dicano cose in contraddizione tra di loro e le rispettive filosofie non siano affatto sovrapponibili). L’antispecismo “classico”, quindi, non esiste come “antispecismo” e coloro che ne sostengono l’esistenza barano. Ma anche ammesso, e non concesso, che quelle di Singer e Regan siano filosofie antispeciste nel senso pieno del termine, occorre ribadire allora che l’antispecismo “classico” nasce già diviso e che tutti i successivi tentativi di sottoporlo a critica e di differenziarsene rispondono all’esigenza di ricomporre un quadro teorico che appare frammentato e incoerente.
L’inesistenza dell’antispecismo pratico
Perché allora negli anni ’80 si comincia a parlare di “antispecismo”? Questo concetto nasce e si diffonde come un’etichetta che vuole descrivere la prassi di gruppi animalisti. Non è dunque una categoria teorica. Ricordiamo infatti che “lo specismo” non esiste nei testi di Singer e Regan, esistono argomentazioni “speciste” ma non lo specismo. Dunque contro cosa combattono questi gruppi? Non si sa. Forse che l’antispecismo nasce almeno come una “filosofia della prassi”, cioè un tipo di azione ben definito nelle sue premesse e nei suoi obiettivi? Piacerebbe pensarlo ma non è nemmeno così. L’antispecismo è un termine che va a sovrapporsi allo stesso genere di attività che i gruppi animalisti svolgevano prima che fosse coniato tale termine. Il cambiamento che esso apporterà, in progresso di tempo, sarà di unificare tali attività sotto un’etichetta unitaria in modo via via più coerente, in un processo che ancora non si è concluso. Come vedremo in seguito questa “coerenza” se all’apparenza sembra un valore positivo produrrà invece effetti negativi sulla stessa prassi del sedicente movimento antispecista.
Le direttrici dell’azione animalista tradizionale prima e dopo il 1975 sono essenzialmente tre:
– diffusione del vegetarismo
– lotta alla vivisezione
– denuncia degli abusi di animali in circhi, zoo ecc.
(ce n’è una quarta di cui parlerò tra poco perché si diffonde dopo il 1975)
Si tratta di attività che rientrano nei tradizionali canoni del volontariato e dell’impegno culturale e civile con la sostanziale differenza che, in questo caso, i soggetti da “proteggere” sono animali non-umani. Quando si inizia a parlare di antispecismo, cioè di lotta allo specismo, queste attività proseguono esattamente come erano iniziate: piccole società e gruppi informali organizzano banchetti e proteste tentando di convincere la maggioranza della popolazione ad assumere comportamenti meno violenti nei confronti dei non-umani. Agli argomenti di tipo morale, si affiancano talvolta argomenti di tipo strumentale (la carne fa male, la sperimentazione non è vera scienza, gli zoo sono diseducativi). L’emergere dell’etichetta “antispecismo” non cambia una virgola del tipo di attività che questi gruppi svolgono e non potrebbe essere altrimenti: poiché lo “specismo”, secondo Singer e Regan, è un semplice pregiudizio morale è chiaro che la lotta contro lo specismo così inteso rientra perfettamente nelle abitudini consolidate di questi gruppi. “Convinci più persone che puoi e il mondo cambierà!” è il motto di ogni attività di tipo morale: come se lo schiavismo, il patriarcato, il capitalismo fossero sorti per la “cattiva volontà” di qualcuno (e, dunque, avrebbero potuto anche non esistere se qualcuno non avesse “ceduto” alla tentazione di agire in modo “malvagio”) e si fossero diffusi e si perpetrassero per cattiva volontà. La lotta allo specismo prende la stessa via, combatte un pregiudizio morale immaginando che lo sfruttamento sia sorto in conseguenza di tale pregiudizio o che la causa di tale sfruttamento vada comunque cercata nella sfera morale come conseguenza di una volontà volta al male, piuttosto che come un fenomeno complesso, prodotto da cause diverse, in cui l’arbitrio individuale gioca solo un ruolo subordinato e comunque mai quello decisivo. Oppure i vegetariani si sono convinti che se il consumo di carne è aumentato in modo esponenziale negli ultimi 50 anni ciò è dovuto al fatto che gli individui umani sono diventati esponenzialmente “più” egoisti? Più che il comportamento individuale dei consumatori, il massacro industriale degli animali si spiega con il bisogno di profitto di poche multinazionali e col fatto che tale profitto necessita della riduzione della natura a “oggetto” e dei lavoratori a fornitori di manodopera a basso costo. Cose che obbediscono alle leggi dell’economia politica e della sociologia, non della morale e che dunque quest’ultima è incapace di spiegare.
L’unico cambiamento che comincia a notarsi nei gruppi sedicenti “antispecisti” è la richiesta di una sempre maggiore coerenza: chi lotta contro il pregiudizio morale lo fa come un fine in se stesso e dunque poco gli dovrebbe importare se la carne fa male, la sperimentazione non è vera scienza e gli zoo sono diseducativi. L’antispecismo, ponendo al centro la lotta allo specismo (inteso come mero “pregiudizio morale” e non come “prassi storica e sociale di sfruttamento”), si identifica allora con la tendenza a rendere sempre più coerenti gli asserti e i comportamenti dei gruppi che sotto le sue bandiere si pongono.
L’emergere dell’egemonia vegana
Oltre alla rinuncia agli argomenti strumentali questa tendenza impone uno spurio connubio tra antispecismo e veganismo. Chi infatti sostiene che antispecismo e veganismo siano la stessa cosa, dimentica che il veganismo esiste dagli anni ’40 come una forma di vegetarismo portato alle estreme conseguenze. Basta leggere i primi numeri della fanzine della Vegan Society per rendersi conto di come il veganismo fosse essenzialmente considerato una “dieta” che oltre a ridurre al minimo la violenza sugli animali domestici faceva anche “bene alla salute”. Vengono presentati anche di sfuggita argomenti che legano il progresso civile dell’umanità all’abbandono del carnivorismo ma si tratta per lo più di suggestioni mistiche (ammantate, come ogni misticismo, di riferimenti pseudo-scientifici) che oggi definiremmo new age. I vegetariani tentavano con l’esempio individuale e la predica morale di convincere il prossimo a cambiare stile di vita, convinti che prima o poi sarebbero riusciti a convertire diversi miliardi di esseri umani uno ad uno. I vegani sono dell’identico avviso: non pensano affatto che la lotta dei vegetariani sia senza speranza perché affidata al buon cuore del prossimo in una società la cui legge fondamentale è l’indurimento dei cuori; piuttosto pensano che tale lotta debba semplicemente diventare più coerente (anche se così facendo la possibilità di produrre un cambiamento immediato nelle abitudini alimentari del resto della società umana diventa miserrima).
Nasce così una “filosofia vegan” che è tutt’altra cosa dall’antispecismo benché tenda purtroppo a confondersi con quest’ultimo: tale “filosofia” coincide con lo sforzo di “diventare vegan”…in effetti “essere” vegan è impossibile, perché dato il principio che impone di rifiutare le conseguenze violente delle nostre azioni sugli animali non umani sarà sempre possibile immaginare un comportamento più coerente e così all’infinito (ma c’è anche chi salta giocondo i passaggi e passa direttamente al fruttarianesimo radicale e all’estinzionismo: “l’unico vegano coerente è il vegano morto”). Il veganismo diventa sempre più lo “stile di vita” ufficiale degli antispecisti ed inizia ad esercitare una diffusa egemonia nell’ambiente: se non si è vegani non si potrà avere alcuna voce in capitolo nel movimento stesso e, quel che è peggio, ogni teoria e ogni azione, per essere accettate come “rigorosamente antispeciste”, dovranno passare per le forche caudine del veganismo. Ma il veganismo è una prassi di testimonianza individuale, non ha alcun effetto reale immediato sulle vite degli animali, dunque pretendere di misurare la teoria e la prassi di un movimento (cioè di una realtà collettiva, di una forza sociale che dunque agisce su un piano diverso dai singoli individui) in base alla coerenza rispetto all’opzione vegana è del tutto privo di senso.
Se avessimo dovuto giudicare per la loro “coerenza” le idee di Voltaire che otteneva profitti dal commercio di schiavi o di altri importanti filosofi illuministi che credevano nell’inferiorità delle altre “specie” umane (Hume), esse sarebbero dovute essere condannate e non avrebbero mai avuto l’influenza enorme che invece ebbero sulla società occidentale. Esigendo massima coerenza di vita e di pensiero da tutti i pensatori e attivisti dell’epoca non avremmo avuto né illuminismo, né rivoluzione francese, né liberazione degli schiavi! Oppure, immaginiamo cosa sarebbe accaduto oggi se nei paesi arabi ogni gruppo avesse preteso di scendere in piazza solo con i propri ristretti aderenti e, ad es., i fratelli musulmani si fossero rifiutati “per coerenza” di marciare accanto ai liberali o viceversa. La conseguenza è abbastanza semplice da immaginare: non ci sarebbe stata nessuna rivoluzione araba. Agire in termini politici, cioè come forza sociale e non come individui (o come un gruppo in sé integralmente coerente ed omogeneo di individui) significa appunto ragionare non secondo l’etica dell’intenzione (agisco in modo coerente con i miei principi) ma anche secondo l’etica della responsabilità (agisco in modo che le mie azioni trasformino la realtà)[6].
Come vedremo in seguito, l’emergere dell’egemonia vegana all’interno del sedicente movimento “antispecista” costituisce un problema insormontabile anche e soprattutto per coloro che vorrebbero un mutamento di paradigma, cioè vorrebbero fare dell’antispecismo una forza con un orizzonte di trasformazione sociale radicale e dunque politico.
Dalla coerenza pratica (veganismo) alla coerenza teorica (abolizionismo e “argomenti diretti”)
L’altra novità che si affianca al veganismo e che sempre più qualifica l’attività di gruppi animalisti che cominciano a definirsi “coerentemente” antispecisti è l’abolizionismo: cioè l’idea che la schiavitù animale vada abolita, non mitigata. Assunto pienamente giustificato, sia chiaro, dal quale però non deriva affatto, come vorrebbero la maggior parte degli abolizionisti, che ogni forma di riduzione della sofferenza animale sia un male e chi lo propugna sia un “nemico della causa”. Lo slogan diffuso da Tom Regan – “vogliamo gabbie vuote, non gabbie più grandi” – doveva indicare l’obiettivo strategico della liberazione, non la prassi immediata che gli attivisti devono seguire anche nella lotta quotidiana. Ma la definizione dello specismo come “pregiudizio” rende impossibile distinguere tra strategia e tattica poiché la richiesta di liberazione, intesa come semplice esigenza morale, non può che essere pretesa totalmente, qui e ora. Un’azione o è morale o è immorale, non esiste via di mezzo. Si confonde così il fine politico o l’ideale regolativo che deve dare senso alle nostre azioni quotidiane, con queste stesse azioni che però, per loro natura, non possono realizzare proprio nulla ma solo indicare o, peggio, testimoniare quel fine che vedono lontano, irraggiungibile di fronte a loro. La liberazione totale, per definizione, non può essere realizzata da nessun atto particolare…eppure è questo che si pretende. Con l’aggravante che, chi non è dello stesso avviso, viene tacciato di fiacchezza morale.
Il liberazionismo
Mentre la filosofia vegan e l’abolizionismo rimangono sostituti imperfetti e teorici dell’antispecismo – poiché scontano la contraddizione permanente tra ciò che un individuo può fare in questa società e lo scopo finale che vorrebbe raggiungere – il liberazionismo è il tentativo di risolvere questa contraddizione scegliendo di entrare direttamente in collisione con la società stessa e, dunque, di passare nell’illegalità. Si tratta ovviamente di una prassi che solo pochi individui scelgono effettivamente di seguire, sebbene il supporto convinto ad esso sia ampiamente diffuso nel movimento. Anzi, in un certo senso si può dire che il diffondersi di questa prassi e, ancor di più, del consenso ad essa, accompagni l’autopercezione dell’antispecismo come “movimento”.
Tra la seconda metà degli anni ’70 e i primi anni ’80, infatti, emerge una componente animalista più radicale che, riprendendo la tradizione dei sabotatori zoofili dell’800, inizia azioni di liberazione di individui animali dalle gabbie. Questa forma della prassi animalista va ad aggiungersi alle tre viste sopra come forma più diretta di opposizione allo sfruttamento animale. L’ALF è la componente non-violenta di queste frange emergenti, legata sempre più ad un immaginario “anarchico”: un ambiente in cui troverà i primi attestati di solidarietà, seppure non senza ambiguità. Infatti, non solo il sodalizio tra liberazionismo e anarchismo tradizionale non è mai stato facile (sono i liberazionisti, per lo più, a definirsi “anarchici”, una definizione “politica” che chiunque, come si sa, può rivendicare senza problemi: la galassia anarchica è forse l’unico altro luogo, dopo l’antispecismo, in cui si può sostenere tutto e il contrario di tutto), ma anche il collegamento tra liberazionismo e antispecismo “classico” è problematico. Non solo perché accanto all’ALF in questo filone si inseriscono anche gruppi che predicano la violenza “riparatrice” contro gli umani (e che quindi difficilmente potrebbero essere definiti “antispecisti”: Animal Rights Militia, Justice Departement ecc.), ma è la stessa pratica di liberazione non violenta che non riceve alcuna “copertura” teorica da parte dell’antispecismo classico. Il sogno di Singer di una “liberazione animale” (da realizzarsi attraverso la discussione razionale e il graduale avanzamento morale complessivo della società) viene qui infatti presa alla lettera e diventa l’incubo di tutta la filosofia cui il liberazionismo pretende a volte ispirarsi. Nonostante, infatti, l’unica filosofia in difesa degli animali cui possono far riferimento i liberatori sia quella di Singer e/o Regan, questi ultimi prendono ufficialmente le distanze da ogni azione illegale e da ogni profanazione del sacro principio della proprietà privata.
In conseguenza di ciò, i liberatori tentano di colmare il vuoto teorico con definizioni inadeguate. Se i liberazionisti all’inizio parlavano di lotta contro “l’imperialismo umano”[7], oggi cedono spesso e volentieri alla mitologia “primitivista”, mostrando tutta l’inadeguatezza politica del proprio approccio al problema dello specismo.
In alternativa, essi rifiutano la filosofia tout court celebrando una forma di prassismo allergico ad ogni riflessione teorica. Questo atteggiamento trova un proprio analogo in molti altri gruppi umanisti “radicali”, con l’aggravante che qui l’essenza dello specismo, cioè del problema che i liberatori vogliono risolvere, non è stata ancora affatto compresa. Per farlo occorrerebbe proprio quella riflessione teorica che si reputa, però, irrilevante. Così, come ho scritto altrove, si pretende di risolvere un problema sistemico (la violenza istituzionalizzata e universale contro gli animali) con azioni di tipo locale e individuale (dagli effetti inevitabilmente temporanei), attaccando la singola proprietà e non il sistema della proprietà.
Questo vale per tutta l’importante e necessaria attività di volontariato nei confronti delle vittime animali della società: attività che non si eleva e non può elevarsi ad un piano politico a prescindere dalla buona volontà di chi la mette in pratica. Salvare un animale sta allo specismo come la Caritas sta al capitalismo. Il capitalismo è un sistema che produce oppressione e miseria e, dunque, non lo si combatte “prendendosi cura” dei poveri e sperando che il nostro esempio convinca la maggioranza delle persone ad imitarci. Il “buon cuore” è una categoria morale, non politica. Categorie politiche sono quelle che identificano le cause dell’oppressione e le vie per superarla strutturalmente (non per lenirne temporaneamente gli effetti), evidenziare i rapporti di forza, il metodo di organizzazione, discussione ed elaborazione delle tattiche e delle strategie.
L’equivoco dell’antispecismo politico
Diffusosi negli ambienti squatter degli anni ’80-’90, l’antispecismo diventa presto anche un’etichetta “politica” che aspira a collocarsi accanto all’antisessismo e all’antirazzismo in una Santissima Trinità di pensiero e azione “corretti”. Si tratta appartenente di un progresso: giovani militanti animalisti si organizzano, frequentano luoghi “politici” e guadagnano lentamente e faticosamente attenzione e rispetto da altri militanti “umanisti”. Fu vera gloria? Insomma. Quella che viene praticata nei luoghi di “resistenza” urbana – dopo la svolta moderata del quadro politico istituzionale e il “riflusso” di fine anni ’70 che ha di fatto rovesciato lo slogan ricco di tensione “il personale è politico” nell’innocuo “il politico è il personale” – è una forma di testimonianza residuale in cui si è persa la capacità organizzativa della “vecchia” politica di massa ma non i vizi del vecchio lupo politicante. Così, se da un lato tutto si riduce ad una sorta di “volontariato” permanente di singoli attivisti, dall’altro le dinamiche autoritarie sopravvivono alla scomparsa della Politica con la “P” maiuscola: il leaderismo “carismatico” sostituisce quello “burocratico”, i gruppi sedicenti libertari si omogeneizzano in uno stile di vita, di linguaggio e di pensiero “alternativi” che, proprio nella loro “alternatività” ai modelli dominanti trovano la propria definizione negativa, il proprio limite invalicabile e la ragione profonda del proprio perpetuarsi identitario. L’impegno politico vissuto “in prima persona”, senza la mediazione delle forme organizzate, si fa esso stesso moralistico, così come la lotta politica diventa affermazione della propria superiorità morale rispetto all’altro. Non solo rispetto al mondo capitalistico, vissuto in toto come mera degradazione morale, ma anche all’altro militante che non si allinea alla propria visione “corretta” e verso il quale non è possibile alcuna dialettica: la logica della mediazione – tipica della politica classicamente intesa – viene rigettata integralmente perché confusa con “l’arte del compromesso”. La mediazione – che andrebbe propriamente intesa come capacità di comprendere ciò che produce e tiene assieme le contraddizioni del reale – viene ridotta alla mera abilità di “mediare” – cioè tenere insieme per puri interessi tattici ciò che rimane incompreso nella sua diversità – e conseguentemente rifiutata in modo astratto. Queste dinamiche, tipiche del movimentismo “umanista”, diventano parossistiche in quello animalista che di politico – nel senso “forte” del termine – non ha mai saputo nulla e nulla sa. L’antispecismo politico se è mai nato, è nato morto (e dunque Leonardo Caffo può risparmiarsi la fatica di confutarlo…).
Ma noi siamo politici!
Quando faccio notare questo tipo di dinamiche alcuni militanti vegani, antispecisti e convintamente “politici” protestano. Ma il fatto è che non basta avere idee politiche o imitare la prassi attuale dei movimenti umanisti per definirsi antispecisti politici. Se infatti l’impegno antispecista riproduce i modelli attualmente dominanti della politica umanista inevitabilmente ne imita la prospettiva ridotta, individualistica e moraleggiante. Unire antispecismo e antirazzismo o antispecismo e antisessismo non dà alcuna garanzia di essere riusciti a superare l’impasse in cui è bloccata tutta la politica antagonista di oggi. Il moralismo è una piaga che attanaglia anche i movimenti umanisti: si legga cosa scrive Valeria Ottonelli nel suo libro La libertà delle donne:
Che cos’è il “femminismo moralista”? E’ una posizione culturale e politica che, nel nome della libertà delle donne e della loro “dignità”, assume un atteggiamento censorio, nei confronti degli uomini ma anche e soprattutto delle donne stesse. Secondo questo tipo di femminismo la liberazione delle donne deve avvenire attraverso una trasformazione intima di tutti i membri della società, che possa condurre ciascuno a capire quali sono i veri valori, il vero bene, il vero uso del proprio corpo, della propria sessualità e dei propri talenti[8].
Basta cambiare qualche termine per avere un’esatta descrizione del tipo di pratica che trionfa nel sedicente movimento antispecista: la liberazione animale arriverà quando si sarà realizzata “la trasformazione intima di tutti i membri della società”. Altro esempio: la critica della Lega fondata su una denuncia del suo “razzismo” impedisce di capire le profonde ragioni economiche del successo che questo sgangherato movimento ha avuto nel Nord Italia. Per quanto lodevoli, i movimenti antirazzisti non sono in grado di comprendere fenomeni come questo e, dunque, nemmeno di fornire plausibili vie d’uscita alla crisi di cui il razzismo è spia ed effetto, non causa. Se l’antispecismo aspira ad ottenere gli stessi risultati dell’antirazzismo e dell’antisessismo si condanna all’irrilevanza sociale e a farsi mero movimento di testimonianza esistenziale. Con buona pace dei suoi propositi di liberazione “definitiva” degli animali.
La prova del nove: il ricatto vegano
In sostanza anche gli antispecisti più politici sono, al meglio, vegani che, grazie alla propria consapevolezza politica, vedono i limiti della “filosofia vegan” pur senza poterli superare. Essi rimangono ostaggi del proprio essere vegan e dell’incapacità di pensare in modo articolato lo specismo, cioè di superare la visione dello specismo come semplice pregiudizio morale. Solo se si supera questa visione, infatti, è possibile distinguere antispecismo e veganismo: il primo rappresenta l’ideale regolativo di una società liberata cui sarà possibile giungere solo attraverso un’azione che coinvolga più soggetti, coordinata e a lunga scadenza; il secondo è una prassi di testimonianza individuale del proprio impegno per gli animali. Antispecismo e veganismo, perciò, non sono affatto la stessa cosa, né sono due aspetti della stessa lotta (ad es. quello teorico e quello pratico, come io stesso avevo inizialmente sostenuto qui e qui). Semplicemente, data la concezione morale tipica della filosofia “animalista” da Singer in poi, e dato il diffondersi dell’antispecismo come mera richiesta di coerenza tra idea e comportamento individuale negli anni ’80-’90, essi sono giunti a sovrapporsi per la quasi totalità degli attivisti, con grave danno sia per la teoria che per la pratica.
Poiché il veganismo come “stile di vita” viene identificato con l’antispecismo, ecco che ogni tentativo di uscire da questa rigida identificazione è sentito internamente o condannato esternamente come inconseguente e contraddittorio. Due esempi che mi hanno fatto molto riflettere. Il primo è un caso di auto-censura, il secondo di censura esterna. In entrambi i casi il soggetto che censura il pensiero che tenta di uscire dalla gabbia riportandolo prontamente sui binari della sua rassicurante “filosofia” è lo stesso: il vegano dentro di sé e il vegano esterno.
Il primo caso è un bell’articolo di Antonella Corabi intitolato Diffondere lo stile di vita vegan: una critica. L’articolo, criticando (giustamente) la fissazione allo stile di vita vegan, nonché la sua “essenzializzazione”, arriva inevitabilmente a minare l’opposizione stessa tra veg*ani e non-veg*ani. Questo problema però viene accennato, poi considerato irrilevante e alla fine dimenticato, tornando ad affermare la necessità e/o l’inevitabilità di assumere uno stile di vita vegan. Ora, io sono d’accordo con la conclusione iniziale, ovvero che non esiste – e se esiste è politicamente irrilevante – un confine netto tra veg*ani e non-veg*ani. È la conclusione a lasciarmi perplesso. Quando, infatti, dopo aver problematizzato il veganismo, si cerca di “recuperarlo”, l’autrice afferma che la scelta veg è una conseguenza “logica”. Questo mi pare molto problematico. Perché se la scelta veg è “logica” lo è perché si è ragionato negli stessi termini di coloro che vengono accusati di assumere uno stile di vita vegan, cioè sulla base dell’idea che diventando vegan si fa realmente qualcosa per cambiare la condizione degli animali non-umani (l’autrice dice anche che essere vegan “rappresenta un gesto di forte opposizione al sistema”…cosa che potrebbero dire tutti i vegan che sono stati da lei criticati nelle righe precedenti!). Ma se non è così (e Antonella ha argomentato benissimo che non è così!), allora la scelta non è tanto “logica”, quanto “emotiva”: si smette di mangiare carne perché non si sopporta l’idea che alla carne sia legata la sofferenza di un altro essere animale. Ma in quanto tale, cioè dettata da un istinto di compassione, la scelta vegan non può essere “necessaria”, perché è per definizione non-calcolabile e non prescrivibile[9].
Il secondo è invece il caso dell’appello che il Comitato Antispecista Milano ha lanciato in occasione del 25 aprile 2012 intitolato “Contro il dominio della specie padrona”. L’invito a costituire uno spezzone antispecista al tradizionale corteo della liberazione ha suscitato subito vive proteste. Non per quello che, a mio avviso, avrebbe dovuto essere criticato in una visione che si vuole politica: ovvero la “spoliticizzazione” implicita in ogni discorso che parla genericamente di “specie padrona” mettendo sullo stesso piano vittime e carnefici del dominio, bensì per il disclaimer con cui il Comitato ha pensato (bene) di chiudere il proprio appello:
DISCLAIMER: il comitato antispecista milanese non è una cooperativa di dietologi quindi cosa mangi o cosa non mangi non ci interessa!
Le polemiche da parte dei vegani sono infuriate subito tanto da costringere lo stesso Comitato a precisare in una nota successiva la propria posizione in merito. Inutile dire che le critiche erano invariabilmente le stesse: se “non vi interessa” cosa mangiano gli aderenti al corteo allora siete “incoerenti”, complici degli assassini ecc. Il meccanismo di colpevolizzazione moralistico del veganismo entra subito in azione, nel modo prevedibile, automatico e asfissiante che ognuno conosce. L’orizzonte del pensiero che tenta di schiudersi si chiude immediatamente e rimane solo lo spazio per assicurare sé e gli altri circa la propria coerenza e correttezza. Duole vedere che nella sua nota in merito all’accaduto il Comitato abbia difeso la propria posizione non mettendo in discussione questa egemonia del veganismo che spoliticizza dall’interno il pensiero antispecista, bensì, di fatto, sostenendo che essere gentili nei confronti dei non-vegani è un modo per facilitare il dialogo. Riaffermando così, ancora una volta, quell’egemonia e confermando che anche i più politici tra i militanti restano invischiati nel ricatto morale con cui il veganismo impedisce ogni matura formulazione di una filosofia autenticamente antispecista.
Riassunto: il carnevale dell’antispecismo
A partire dagli anni ’80, l’ingrossarsi delle fila dei vari gruppi “antispecisti” si è legato alla diffusione delle idee di Singer e Regan così che la sovrapposizione tra questi due processi ha creato l’illusione che crescesse un “movimento”, dotato di una prassi e di una teoria più o meno coerenti. La seconda ondata di teorici (Dunayer, Francione) non ha fatto altro che confermare l’esistenza di un fenomeno (lo “specismo”) di cui nessuno aveva fornito una descrizione adeguata e questo ha retroagito sull’auto-percezione del movimento stesso, alimentando l’illusione collettiva di cui il movimento è vittima. Questa situazione prosegue ancora oggi, gli insuccessi pratici e l’incapacità di condurre una discussione razionale sui nodi fondamentali di una teoria che non c’è, sono la prova provata di tale situazione. L’emergere dell’egemonia vegana e il sovrapporsi di antispecismo e veganismo ha fatto il resto.
Parliamoci chiaro: nel sedicente movimento antispecista, se un militante grida “vivisezionate i pedofili” è bene accetto ad una manifestazione, sicuramente più di uno che magari è contro la vivisezione ma “mangia la porchetta”. Quest’ultimo lo si vorrebbe allontanare perché “incoerente”, il primo no. Al massimo li si vorrà allontanare tutti e due. Ma io sostengo con forza che, dal punto di vista della costruzione di un soggetto politico, è molto peggio e deleterio il primo comportamento rispetto al secondo. Purtroppo, come ho detto all’inizio, le tesi “estremiste” sono ben diffuse e ben accette, tanto non esiste criterio né teorico né pratico per metterle alla prova. Nei movimenti umanisti coloro che pensano e gridano “impicchiamo Marchionne”, “distruggiamo l’occidente corrotto per far vivere felice il terzo mondo” o “i maschi sono geneticamente tarati, le donne dovrebbero governare il mondo senza di loro” sono una sparuta minoranza di pazzoidi cui nessuno dà ascolto. Nel sedicente “movimento” antispecista invece sono una discreta fetta dei “normali”. E, quel che è peggio, anche una parte dello strato più intellettuale e consapevole è attratta dall’idea secondo cui l’umanità è una specie “malata” che se non ci fosse sarebbe meglio per tutti. Tesi come questa rendono del tutto senza senso l’attivismo cui con tanta fatica e impegno pure ci si dedica. Che senso ha agire per migliorare la condizione degli animali se si considera l’umanità, in blocco, come un gruppo di irrimediabili “assassini”? Ogni azione diventa un’assurda lotta contro i mulini a vento, una fatica di Sisifo in cui l’unica soddisfazione, a volte, è l’autocompiacimento per il proprio essere “diversi”. Ma come si può condannare l’umanità da “umani”? Non è un gesto contraddittorio?
I presupposti di un antispecismo autenticamente politico
Come ho argomentato altrove, un’impostazione propriamente politica della lotta allo specismo dovrebbe essere in grado di
(1) Concepire il fine dell’azione come realizzazione di una società liberata
(2) Elaborare la distinzione tra obiettivi tattici e strategici
Il cambiamento auspicato, dunque, non andrebbe inteso in senso individuale ma collettivo. Inoltre esso andrebbe articolato nel tempo in una visione progressiva che conduca dallo stadio sociale presente allo stadio futuro attraverso la rottura/trasformazione di tutti i vincoli (culturali/istituzionali/politici/economici ecc.) che impediscono di fatto tale trasformazione. Da questi due elementi ne derivano altri due non meno importanti per l’antispecismo:
(a) Cercare la mediazione tra interessi umani e interessi non-umani
(b) Cercare la mediazione tra movimenti umanisti e antispecisti
L’idea di una società liberata (1) rappresenta lo stato di conciliazione tra interessi altrimenti divergenti (a). Non può infatti esistere azione politica che non sia rappresentanza di un interesse e gli interessi degli animali umani sono altrettanto necessari e legittimi di quelli dei non-umani. In seconda istanza, partire dall’idea di una società liberata (piuttosto che dell’agire immediato “coerente” dei singoli attivisti), permette attraverso l’elaborazione di una strategia a lungo termine (2), anche di trovare i possibili agganci con gli altri movimenti politici “umanisti” (b), permettendo di identificare obiettivi tattici e strategici condivisi senza i quali non è immaginabile alcuna trasformazione sociale. Gli antispecisti sono parte della società, non sono e non saranno mai la società ed è ora che essi traggano le conseguenze da questo semplice dato di fatto. Una società non specista, se ci sarà, sarà la conseguenza di una liberazione effettiva della società di classe dalle logiche del dominio, non la progressiva “conversione” dei suoi membri all’antispecismo o, peggio, alla “filosofia vegan”.
Tutto ciò è reso oggettivamente impossibile dalla definizione di specismo come pregiudizio morale. Solo se lo specismo è pensato come fenomeno storicamente e socialmente determinato la lotta contro di esso può assumere la forma di una progressiva opera di smantellamento di un ordine che eccede le singole volontà degli umani catturati, assieme agli animali, nel suo ingranaggio istituzionalizzato. Se si assume l’ottica dello specismo come pregiudizio morale, invece, l’unione tra interesse umano e interesse non-umano verrà visto come un cedimento all’ideologia antropocentrica e specista, l’idea di un’azione collettiva e articolata, composta di soggetti politici diversi e con un fine non immediato ma a lunga scadenza non identificandosi con il veganismo, l’abolizionismo e il liberazionismo verrà giudicato immorale ecc. ecc.
Sono perfettamente consapevole che questo richiamo alla politica “classica” può suonare anacronistico e anche ingeneroso nella misura in cui la crisi di quel modo di fare politica negli anni ’70 è stata (anche) la conseguenza dell’alto livello di “disumanizzazione” cui ha condotto una visione sclerotica della forma-partito e una visione eccessivamente totalizzante della politica stessa che estraniava gli individui dalle proprie esistenze personali per darli in pasto allo scontro ideologico. Ma questa è solo una parte della verità. Se la politica che supera la sfera dell’individuo per farsi partito, istituzione, movimento organizzato ecc. fa oggi paura perché sembra voler riproporre quell’alienazione delle singolarità dentro schemi oggettivi e universalistici, non è nemmeno possibile agire come se la reificazione non esistesse. Contro le istituzioni che agiscono in modo anonimo e producono effetti su scala mondiale, i singoli individui sono impotenti, oggi come ieri. Solo la forza d’urto di un movimento organizzato in cui i singoli investono parte della propria esistenza in un progetto condiviso, con solide basi teoriche che permettono un’analisi oggettiva dei problemi, con tattiche di lotta che si inseriscono in una strategia a lungo termine può sperare di scalfire quel potere. E quel potere va sconfitto nella sfera della produzione sottraendo spazio di manovra al capitale, non nella sfera del consumo, dove il capitale celebra già il proprio trionfo nell’eterna metamorfosi della merce-lavoro. Il sistema della proprietà non si sconfigge chiedendo prodotti “cruelty free”, ma esigendo una produzione generalizzata fondata sull’eguaglianza e sul benessere di tutti gli individui (umani e non-umani).
L’individuo è il fine, non può essere il mezzo. Agire come se oggi l’individuo fosse già al centro della scena politica, come se il mondo della necessità fosse già oggi il mondo della libertà, significa scambiare i propri desideri con la realtà. È vero che sembra impossibile trasformare la società e realizzare questa centralità dell’individuo passando per altre strade che non siano l’individuo stesso: sembra sorgere una contraddizione tra il fine e i mezzi. Ma questa è proprio la contraddizione che occorre afferrare e risolvere, non aggirare attraverso l’apologia del soggetto sovrano. D’altronde, basta fare la controprova: trent’anni di lotte “dal basso”, di impegno “individuale” in ambito di politica del lavoro hanno portato allo smantellamento dei più elementari diritti dei lavoratori costruiti in duecento anni di politica “alienata”. E se oggi il capitalismo trema e si intravede finalmente lo scorcio di un paesaggio sociale diverso all’orizzonte, ciò accade, come al solito, per le sue contraddizioni, mentre non esiste soggetto politico in grado di trarre profitto da questa crisi.
[1] So già che qualche attivista mi obietterà che questo tipo di riflessione critica viene fatta. Ma qui parlo delle dinamiche del movimento, non dei suoi singoli attivisti che sovente si innalzano al di sopra del livello medio di coscienza pur non potendo far nulla per modificare quest’ultimo. È questa incapacità, che non è un difetto soggettivo ma la conseguenza di una caratteristica strutturale, oggettiva, del movimento che mi interessa.
[2] Cfr. M. Maurizi, Al di là della natura. Gli animali, il capitale e la libertà, Novalogos, Aprilia 2011.
[3] Anni fa proposi una visione dell’antispecismo che volevo distinguere dalle teorie allora (e ancora oggi) in voga nell’ambiente animalista: chiamai il mio antispecismo “storico” per distinguerlo da quello astratto e astorico che ho definito “metafisico”. Una distinzione diversa, ma non meno significativa, è stata proposta da filosofi americani come Ralph. R. Acampora e Matthew Calarco che si sono impegnati a valorizzare autori della tradizione filosofica occidentale classica (da Lévinas a Derrida, da Deleuze a Merleau-Ponty) in chiave antispecista, evidenziando così un filone filosofico che usava concetti e strategie linguistiche completamente diverse da quelle fino ad allora seguite in quest’ambito. Sulla falsa riga di questi tentativi e sull’onda di questa riscoperta della riflessione cosiddetta “continentale”, anche M. Filippi e F. Trasatti, nell’introduzione all’antologia L’albergo di Adamo (Mimesis, Milano 2010), hanno distinto tra un antispecismo di “prima” e uno di “seconda generazione”. Infine, Leonardo Caffo si è inserito in questo dibattito, proponendo una scansione in tre periodi e lanciando recentemente l’ipotesi di un antispecismo “debole”, accanto all’antispecismo “morale” e a quello “politico”. La differenza tra la mia impostazione e quella degli altri summenzionati pensatori, è che io parto non da una diversa concezione dell’antispecismo, bensì dello specismo. In altri termini, poiché io concepisco lo specismo come un fenomeno socio-storico e non come aberrazione morale, l’unica forma di opposizione allo specismo che considero effettiva è una prassi politica e collettiva (dunque non testimoniale e individuale) che combatta lo specismo non come pregiudizio ma come prassi di sfruttamento legata a determinati tipi di organizzazione sociale (e che dunque include inevitabilmente anche una lotta allo sfruttamento umano, senza il quale la società non assumerebbe la logica del dominio come suo fattore costitutivo).
[4] Cfr. M. Maurizi, Al di là della natura, cit., pp. 21 e sgg.
[5] Che oggi lo usano nel senso ampio (che io definisco “metafisico”, cioè astratto e astorico) tipico, ad es., della Dunayer che, non a caso, critica la definizione di Singer.
[6] Cfr. M. Maurizi, La disputa sugli argomenti indiretti: un falso problema.
[7] Ronnie Lee, portavoce dell’ALF, citato in Ph. Windeatt, “Chiaro, ora emerge il collegamento”, in P. Singer (a cura di), In difesa degli animali, Lucarini, Roma 1987, pp. 240.
[8] Ringrazio Maria Giovanna Devetag per avermi segnalato questo interessante testo.
[9] Quando dico che la scelta è emotiva e non logica non sto affatto svalutando l’aspetto emotivo a favore di quello razionale, tutt’altro. Anzi, non penso che possano esserci altri motivi per diventare vegan.
Comments
16 Responses to “L’antispecismo non esiste. Storia critica di un movimento fantasma”Trackbacks
Check out what others are saying...-
[…] come noi. I limiti (e i danni) del proselitismo fine a se stesso, che attivisti come Reggio e Maurizi – ma non sono i soli: pure io, timidamente, ci ho provato – si ostinano […]
-
[…] come noi. I limiti (e i danni) del proselitismo fine a se stesso, che attivisti come Reggio e Maurizi – ma non sono i soli: pure io, timidamente, ci ho provato – si ostinano […]
-
[…] ed improponibili le teorie antispeciste. Non mi dilungo qui nel descrivere il tutto (anzi, invio a questo articolo di Asinus Novus per maggiori dettagli), ma mi limito a fare una domanda: siete disposti a sacrificare la vita di […]
-
[…] superato dall’antispecismo. Ma io ne no sono affatto sicuro. Ho avuto modo di argomentare che l’antispecismo come teoria e come pratica di fatto non esiste. Perché possa esistere bisognerebbe avere delle risposte credibili a domande che rimangono tuttora […]




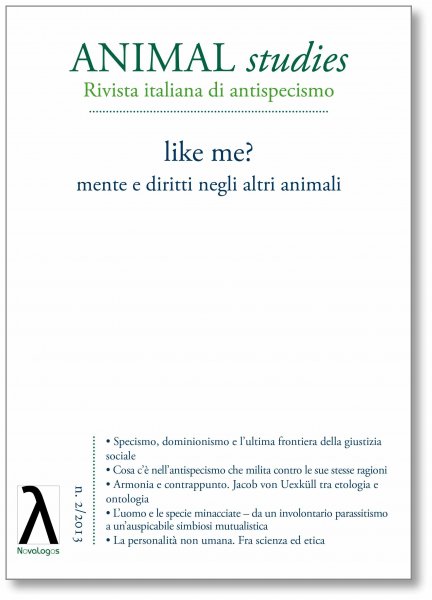
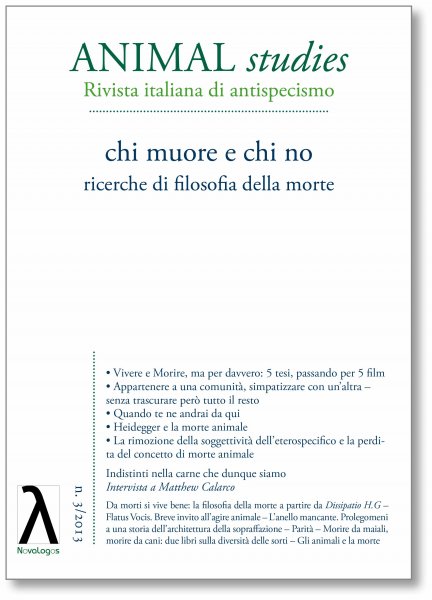
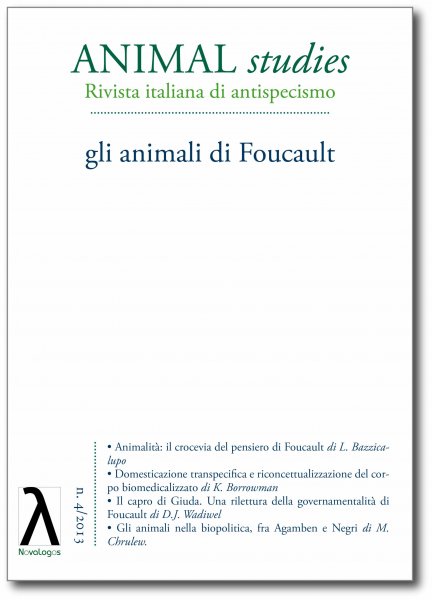


Mecojoni!
Chiaro e lucido come sempre.
Non ho davvero nulla da aggiungere.
L’analisi che hai fatto della nota del Comitato Antispecista Milano (la seconda) è perfetta. In quest’articolo c’è dentro tutto, spero lo inseriscano nei programmi ministeriali o almeno lo distribuiscano con le pagine gialle.
con le pagine gialle, a mio avviso, sarebbe il massimo.
“E se oggi il capitalismo trema e si intravede finalmente lo scorcio di un paesaggio sociale diverso all’orizzonte, ciò accade, come al solito, per le sue contraddizioni, mentre non esiste soggetto politico in grado di trarre profitto da questa crisi.”
Non è proprio il contrario? A me pare che il capitalismo si sia non solo rafforzato, ma si stia rifondando su basi ancora più ciniche che nel passato, quando doveva tener conto di maggi parigini e di regimi comunisti. Ora che anche i paesi del terzo mondo rincorrono il modello occidentale, per il capitalismo è una pacchia fagocitarli meglio che durante il colonialismo e il neocolonialismo.
Ma anche qui parla il mio vedere il mondo tutto nero.
E quanto dissetante è quest’altro tuo articolo!
Condivido tutto. Sono i temi su cui parliamo spesso io e mia moglie. Però. C’è un però… vedo in ogni caso, questa “lotta” una utopia non embrionale, non ancora solo lontana dal concepimento, ma così giovane da essere ancora sterile. Dico questo per due motivi: 1) finché l’uomo non sarà libero e sarà impegnato per se stesso (vedi il problema del dominio che sfocia nei “pratici” conflitti armati, vedi le crisi sociali poveri Vs ricchi, vedi il razzismo, sessismo, etc), parlare di lotta per l’antispecismo (politico, morale, spirituale, etc…) sarà come parlare scandinavo ad uno che parla e capisce solo il dialetto bolognese. 2) chi ha bisogno di riscattarsi (animali non umani) lotta per interposta persona (umani). In nessuna lotta, nessuno ha mai vinto per “delega” di tutti i coinvolti. Penso che, finché il problema dello sfruttamento degli animali non diventerà critico, (come ad esempio l’estinzione dell’animale “cibo”) l’uomo difficilmente potrà prendere in considerazione l’argomento “antispecismo”.
Queste sono mie considerazioni pesonali, cercando di vedere il tema antispecismo a livello “massa” globale, non solo al mio ristretto contesto sociale…
Ho conosciuto di persona un antispecista vegan (episodicamente “antifascista”)(“praticante”)che mi ha ricattata per un lunghissimo periodo convincendomi che se lo avessi lasciato ci avrebbero rimesso gli animali di cui ci occupavamo. Gli animali ci rimettevano mentre, prima che lo conoscessi e dopo che sono scappata via da quel rapporto, intanto per mesi ho preso botte, ho preso ingiurie, ho preso minacce, ha fatto terra bruciata intorno a me, ho boicottato la mia vita sociale e familiare per slegarla dal presente che stavo tentando di vivere con parsimonia di egoismi nel tentativo di riportarlo a semplice chiarezza e pace. Tutto inutile.
Quetsa persona infine, dopo tutto quello che è stato, questa persona e chi con lui ha negato le sofferenze che mi sono state fatte calunniandomi anche pesantemente; mi ha fatto passare la voglia di credere a qualunque vegano o sedicente antispecista, non esiste questa pratica. L’amore,l’empatia, sono una suggestione culturale e spesso un iter fanatico una pratica di esistenza. Lo dimostra la schizofrenia con cui si agisce in maniera maniacale in un ambito e in maniera totalmente opposta e brutale e distruttiva e totalitaria e oscurantista e capitalista, e tutta la roba che nelle apparizioni pubbliche si mette al rogo, nel privato o in contesti “intimi”, o meglio , NON PERSEGUIBILI.
Non ha senso un movimento collettivo se le ambizioni finali sono Risvegliare l’individualità emozionale e sociale del singolo.
Tanti antispecisti vivono una vitaparassitaria della condizione di schiavi e rifugiati in cui versano i non umani… ogni loro parola è ridicola, e ogni loro pratica inutile, se coltivata nella contraddizione e nella persistenza di un ricatto.
.
Maurizi, vorrei inviarti un mio vecchio articolo. Sono quasi 10.000 battute, qui non ci stanno.
finalmente un articolo che spoglia definitivamente il re(il vegan/esimo),arriva al nocciolo della questione(il presunto movimento antispecista) e pone una strategia per liberare la societa’.E’ ora di passare dall’egemonia vegana all’egemonia politica.
Preciso e pulito come discorso è senza imputamenti di nessun tipo sotto l’aspetto pratico e morale della questione. Solo qualche appunto se mi è concesso: in che modo si può non riconoscere come il ‘boicottare’ come uno strumento di vera opposizione critica a ciò che l’istituzione ed il sistema creano? ma giusto nell’aspetto pratico perché capisco che il fine primario sia questo stesso spostamento delle economie su altre i’dentità. Di mercato’.
Altro punto in cui credo Ci sia necessità di un chiarimento è l’aspetto politico perché io personalmente non voglio assolutamente che la politica penetri in alcun modo nell’atto pratico della liberazione
animale, sebbene riesca più strettamente ad assorbire la comparazione tra capitalismo e quindi realtà umane da liberare da una realtà di schiavitù e prigionia., ma se si fa questo parallelismo credo che stiamo solo parlando d’ideologia politica, e se già abbiamo poche persone a partecipare alla liberazione animale ancora meno ne avremo nella liberazione al capitalismo o di qualsivoglia modello economico raffigurante lo schiavismo come modello imperante, di conseguenza credo a mio avviso che sia pericoloso determinare l’ideologia politico come una necessità per contrastare in maniera più ‘sana’ e pulita agli intenti della liberazione animale, anzi altre si lo trovo di pregiudizio se ci si dichiara antispecisti, perché ci si muoverebbe senza alcun confronto aspro su ciò che le persone sono, hanno come ideale o concetto di sorta. Grazie mille
La ringrazio per il gentile commento e le preziose osservazioni.
Come ho scritto altrove il boicottaggio è una forma di protesta che ha senso se è fatta da molti individui nei confronti di un’industria singola (o meglio ancora di un singolo prodotto), è totalmente inutile se fatta da pochi individui (vegan) nei confronti dell’intera industria alimentare.
Sulla seconda questione non credo di aver parlato di ideologia che, come ben saprà, è termine polivoco e ambiguo che io non uso per indicare una visione politica. Per quanto mi riguarda una visione politica è per definizione non ideologica perché analizza i rapporti reali di sfruttamento e tenta di abolirli. Il capitalismo è fondato sullo sfruttamento umano e della natura quindi per abolire lo sfruttamento occorre superare il capitalismo. Cosa c’è di ideologico in questo? A meno che uno non pensi che il capitalismo sia eterno e che quindi nella storia tutto sia transeunte tranne il capitalismo…e questa, sì, la considero una visione ideologica della realtà.
Analisi acuta e coraggiosa. D’accordo quasi su tutto, avevo già notato l’atteggiamento ascetico e settario dei teorici della purezza alimentare. Ma bisogna capirli: è molto più facile friggere il tofu e partecipare ai riti purificatori davanti ad Harlan che organizzare la rivoluzione! L’individualizzazione degli obiettivi di lotta è stato sempre il grande problema dei movimenti perché in genere sottrae spazio all’azione sociale. Generalmente avviene per ripiego e per debolezza. Ma, essendo in grado di disattivare l’efficacia sociale dell’azione politica, è spesso stata “favorita” da coloro che avevano interesse ad opporsi ai movimenti (allo stesso modo dei fondamentalismi in genere, religiosi e non). Attenti ai nemici, in particolare a quelli invisibili.
Poi non sono sicura che “quel potere” vada sconfitto solo nella sfera della produzione e non anche in quella del consumo. La prima cosa non sembra tanto facile, quindi io combatterei su tutti e due i fronti. in fondo se (sottolineo il SE) riuscissimo a mettere in crisi la domanda, ciò si ripercuoterebbe sull’offerta. Io credo che lo sfruttamento animale sia necessario al capitalismo, tanto che uno dei massimi sforzi per il rafforzamento di questo sistema di sfruttamento è stato rappresentato dalla nascita di allevamenti intensivi, che vanificarono i progressi sociali ottenuti con le riforme agrarie.
In effetti non mi sembra che lessere umano in un sistema sano abbia bisogno di carne, altrimenti il buon Dio (o la Natura, come vi pare) lo avrebbe dotato di una dentatura e di un apparato digerente un po’ diversi. Sono convinta che diritti degli uomini e diritti degli animali coincidano e che il sistema che non li rispetta e si basa sullo sfruttamento – un po’ di tutti – sia da rovesciare per mezzo di azioni sociali/politiche.