Teriofobia
Di Marco Maurizi
1. La teriofobia, cioè la “paura degli animali”, è una caratteristica strutturale della civiltà. Essa è divenuta un luogo comune, una delle tante ovvietà che, proprio perché ovvie, nascondono molto più di quanto non dicano a prima vista. “Si sa” che la civiltà ci “protegge” dal pericolo rappresentato dalla natura “selvaggia”. Dall’antichità fino ad oggi, ci rappresentiamo il nostro dominio sul resto del vivente nella forma di una legittima difesa: “il compito principale della civiltà, la sua propria ragion d’essere, è di difenderci contro la natura”.[1] Pur ammettendo che l’intelligenza e la cooperazione abbiano permesso all’umanità di proteggersi dall’aggressione di fiere fameliche e altri pericoli naturali, è del tutto evidente che il nostro attuale dominio sul pianeta, se davvero dovesse giustificarsi in questi termini, dovrebbe qualificarsi come un mostruoso esempio di eccesso di legittima difesa.
2. La realtà, tuttavia, è ben diversa. Ciò che fa paura è semplicemente l’oggetto di una rimozione, ciò che deve essere sacrificato, addomesticato, respinto o, al limite, eliminato perché lo spazio dell’esperienza umana possa chiudersi e compiersi senza resti, ostacoli, disturbi. La civiltà poggia su una contrapposizione tra umano e non-umano che struttura sia materialmente che simbolicamente ogni aspetto dell’esperienza umana. Che si tratti della “natura esterna” prima cacciata e poi addomesticata o della “natura interna” che deve venir coltivata secondo il principio di prestazione vigente, “per fare un uomo” ci vuole il dominio materiale e simbolico sull’animale: sia quello non-umano, sia quello umano[2]. Ed è così che quell’opposizione fondamentale tra umano e non-umano regola tutte le altre opposizioni di cui è intessuta la nostra esperienza sociale: tra “uomo” e “animale”, tra “cultura” e “natura”, tra “razionalità” e “sentimento”, tra “conscio” e “inconscio”, tra “anima” e “corpo”, tra “maschio” e “femmina”, tra “adulto” e “bambino”, tra “residenti” e “stranieri” ecc. Il secondo termine assume sempre il ruolo passivo-negativo-materiale rispetto ad un principio attivo-positivo-formante che deve dominare e mantenersi “puro”, incontaminato dall’Altro. In questo meccanismo che anima la dialettica della civiltà ognuno deve essere disposto a sacrificare una o più forme dell’animalità (sia dentro che fuori di sé) per poter essere ammesso nel cerchio rispettabile dell’umano. In tal senso, come scrivono Adorno e Horkheimer, la storia della civiltà è la storia dell’“introversione del sacrificio”.
L’esistenza naturale, animale e vegetativa, era per la civiltà l’assoluto pericolo…Il ricordo vivo della preistoria, già delle fasi nomadi, e tanto più delle fasi propriamente prepatriarcali, è stato estirpato dalla coscienza degli uomini, in tutti i millenni, con le pene più tremende…L’umanità ha dovuto sottoporsi a un trattamento spaventoso, perché nascesse e si consolidasse il Sé, il carattere identico, pratico, virile dell’uomo, e qualcosa di tutto ciò si ripete in ogni infanzia.[3]
Ciò che resta “fuori” da questo gioco di esclusione/inclusione, rimane come minaccia, ritorna come un fantasma, assilla come un incubo il Sé “identico, pratico, virile” necessario per adeguarsi alla società classista, con i suoi conflitti endemici, la sua violenza diffusa e capillare, la sua logica di prestazione e competizione. Tutto ciò che nega quell’identità, quella praticità, quella virilità è oggetto di paura perché alberga, oscuro e inascoltato, alla radice del meccanismo stesso che, rimuovendolo dall’esperienza “umana”, rende quest’ultima possibile.
3. È ormai da secoli che ci è risparmiata la possibilità di avere effettivamente “paura” degli altri animali, eppure la società capitalistica tecnologicamente sviluppata, totalmente urbanizzata, che non si limita più solo a dominare la natura dall’esterno ma oggi si ripromette di riprogrammarla geneticamente secondo i propri bisogni, continua ad aver paura degli animali non-umani. Questa paura non sarebbe giustificabile se dovesse basarsi sui dati di fatto. Esattamente come nel caso dei fenomeni migratori, allucinatoriamente esasperati dall’opinione pubblica fino a farli diventare “ondate” di “barbari” e “stupratori” a dispetto di ogni statistica, così il ruolo degli animali nella nostra società continua ad essere vissuto come una fantasia delirante e persecutoria.
La strategia linguistica che lo specismo mette in opera per stabilizzare e giustificare l’ordine dello sfruttamento modifica infatti l’esperienza reale del terrore animale preistorico trasformandola in falsità e inganno. A fronte dell’immane potenza con cui le società umane schiacciano sotto il proprio giogo il resto del vivente, la risibile affermazione del “pericolo” rappresentato dagli animali non cessa di risuonare nei titoli strillati dei mass media (si pensi alle consuete notizie allarmistiche sui cani “mordaci”, sulle fughe di “fiere” da circhi e zoo o, di recente, sui “lupi” che, approfittando delle abbondanti nevicate nel centro Italia, sono “tornati” a seminare paura in alcuni paesi) e più sotterraneamente, ma non meno efficacemente, nelle nostre coscienze. Solo se l’altro è reso un “mostro”, è immaginato come più potente e più forte di noi può essere vissuto come minaccia e il nostro atteggiamento nei suoi confronti può assumere i tratti auto-assolutori di un atto di legittima difesa. Si tratta del meccanismo in base al quale viene decretata nell’immaginario la “superiorità degli inferiori” per poterli più comodamente opprimere nella realtà: una “procedura simbolica che fa dell’altro o dell’altra un monstrum, comunque un essere dotato di una potenza o di un potere smisurati o anomali”[4]. Il migrante “sporco” o “stupratore”, la donna “emotiva” o “seduttrice”, l’animale “infestante” o “famelico”: tutti riferimenti ad una natura selvaggia, cieca e indomita cui la civiltà contrappone il proprio ordine razionale, libero e giusto. Come osserva Melanie Bujok, “la paura del non-dominato esige ordine. Il ‘mostro’ animale deve essere chiamato per nome per mantenere la distanza emotiva, cognitiva e sociale e non permettere che alcun dubbio ostacoli il sacrificio degli animali”[5]. In tal modo, “ogni singolo attacco di un individuo animale nei confronti di un umano viene universalizzato come attacco ‘degli animali’ all’umanità che giustifica l’intervento totale e violento delle istituzioni sociali nei confronti di ogni singolo individuo animale. […] Il morso di un cane legittima un’intera epoca di sofferenze per gli animali, […] l’animale viene accusato di essere una possibile minaccia, per potergli negare ogni solidarietà […], per impedire che gli animali possano aspirare alla giustizia”[6]. Il carnefice si discolpa accusando la vittima inerme.
4. Ma la strategia auto-assolutoria dello specismo si muove anche su un altro livello. Essa considera infatti un pericolo non solo l’oggetto della sua rimozione violenta (la natura umana e non-umana “addomesticata” dalla società), ma anche coloro che ricordano questa rimozione e, così facendo, la denunciano. Gli animalisti, i veg*ani e gli antispecisti sperimentano sulla propria pelle l’effetto di ritorno di quella violenza esercitata sugli animali non-umani nella forma di un perenne ostracismo di cui sono fatti oggetto dal resto della società. Tutto ciò non è affatto un caso. Se è vero, infatti, che la “rimozione dell’animale”[7] costituisce lo sfondo su cui si erge l’intera civiltà del dominio, coloro che attestano la propria simpatia verso il non-umano, coloro che ne riconoscono la vicinanza empatizzando con la sofferenza di cui gli animali non-umani sono vittime, coloro che rifiutano di disconoscerne l’abissale diversità, irriducibile al recinto dell’“animalità” cui vorrebbe costringerli la cultura antropocentrica, sono proprio coloro che non accettano quel sacrificio su cui si fonda il “Sé identico, pratico, virile”.
(1) Contro l’identità. Chi denuncia la violenza sugli animali denuncia la falsità su cui è costruita l’identità umana in quanto non-animale, denuncia cioè l’astrattezza di una definizione di “umano” che si fonda su un duplice gesto paranoide: l’accorpamento di tutti gli altri esseri viventi in un calderone indiscriminato (l’Animale) e la costruzione di una barriera gerarchica e auto-immunizzante tra “noi” e “loro”.
(2) Contro l’agire “pratico”. Chi denuncia lo specismo, la prassi di sfruttamento della natura non-umana, denuncia anche il comportamento “pratico” dell’uomo della strada, di chi non vuole sentire tante storie e agisce sicuro di sé perché “si fa così”. Denunciando comportamenti solitamente accettati come “normali”, “razionali”, di “buon senso”, si mostra che tale normalità, tale razionalità, tale buon senso sono 1) dei costrutti sociali e, come tali, non valgono assolutamente ma solo per il tipo di società che si è storicamente imposto; e 2) che tale comportamento è intriso di violenza e di sopraffazione ed è quindi in contraddizione con gli ideali di giustizia, di libertà, di solidarietà che dovrebbero costituire la quintessenza della “civiltà” e che invece, nella loro declinazione antropocentrica, ne rappresentano l’assoluta negazione.
(3) Contro la virilità. Infine, chi denuncia l’indifferenza verso la sofferenza animale denuncia anche il modello psicologico socialmente accettato, ne denuncia lo squilibrio tra razionalità ed emotività. Spesso si accusa chi denuncia la violenza sugli animali di essere “troppo” emotivo (se non, addirittura, “femmineo”) o di pretendere da altri una solidarietà verso gli animali che non può essere “obbligatoria”, poiché sarebbe imperscrutabilmente iscritta nel cuore del singolo e, come tale, non potrebbe essere oggetto di alcuna richiesta perentoria. Questo tipo di considerazioni (su cui, purtroppo, gli stessi animalisti cadono facilmente quando accusano gli altri umani di essere “cattivi”) sorvola su ciò che il sociologo Zygmunt Bauman ha chiamato “la produzione sociale dell’indifferenza morale”[8]. Per spiegare come sia stato possibile che migliaia di tedeschi, cittadini esemplari, educati, spesso culturalmente raffinati, buoni padri di famiglia ecc. avessero potuto partecipare senza remore morali al massacro degli ebrei, Bauman sottolinea come i meccanismi della solidarietà e dell’avversione morale siano socialmente costruiti, come, in sostanza, l’empatia non sia misurabile individualmente bensì socialmente. Gli antispecisti, oggi, testimoniano di una possibilità che l’attuale società nega con tutte le sue forze: che è possibile un’organizzazione sociale diversa fondata non sulla logica della repressione, dello sfruttamento dell’altro, dell’accumulazione e dell’espansione, bensì sull’uguaglianza sociale, sul riconoscimento e la valorizzazione della diversità, sul godimento, il gioco, il dono.
5. Chi ragiona in questo modo, chi chiede il “perché?” dietro ogni violenza istituzionalizzata, chi immagina un mondo diverso, chi testimonia con la propria vita la possibilità di un’altra vita, è allora oggetto di quel terrore panico che coglie ogni membro di questa società quando le pareti della quotidianità vacillano e mostrano come ciò che appare “naturale” e “ovvio” non sia altro che un costrutto, un palcoscenico, una finzione. Ecco allora che chi ragiona contro la razionalità dominante sragiona, è un folle. Chi chiede conto della sopraffazione è un’anima bella, un emotivo che non sa accettare la durezza della vita. Chi apre l’occhio dell’anima al di là dell’orizzonte del presente è un sognatore, un acchiappa-nuvole, uno che non sa “come stanno veramente le cose” (in realtà lo sa fin troppo bene e se lo “stato di fatto” non gli va è disposto ad urlare, assieme ad Hegel, “tanto peggio per i fatti!”). Chi sceglie di rendere la propria vita una testimonianza di questa possibilità negata, chi sceglie di non mangiare carne, di non usare prodotti animali di alcun tipo, è un estremista, un “talebano”, uno che vuole imporre il proprio punto di vista. Certo, è vero che spesso gli animalisti dimenticano che “non c’è vita vera nella falsa”[9] e attribuiscono troppa importanza al proprio “stile di vita”, ma ciò non cambia il ruolo che essi oggettivamente svolgono nell’inceppare il meccanismo del dominio: essi fanno paura, non perché rappresentino un pericolo immediato (nonostante statistiche trionfalistiche sul numero dei vegetariani nel mondo l’antispecismo è ancora consapevolezza di un’esigua minoranza) ma perché rappresentato un pericolo reale e radicale a livello sistemico. Per questo, nonostante la loro esiguità numerica, gli animalisti hanno da sempre suscitato scherno e fastidio, tattiche di dissimulazione della reale percezione del “pericolo” che essi rappresentano per l’attuale ordine sociale. Queste tattiche scattano in modo assolutamente automatico e inconscio nell’interlocutore specista di turno, a dimostrazione di quanto radicata sia la “rimozione dell’animale”. Altra dimostrazione di quanto sia proprio questo meccanismo ad essere solleticato da ogni attestazione di simpatia verso la sofferenza degli altri animali è la terribile stereotipia che caratterizza le risposte. Anche quando vengono pianificate dall’alto in apposite campagne, infatti, è facile constatare l’assoluta prevedibilità e ripetitività delle critiche che la prospettiva antispecista suscita. Esse vanno invariabilmente a difendere quella “identità”, quella “praticità” e quella “virilità” di cui è costituito il Sé dell’uomo civilizzato: ora saranno “ovvie” (e dunque solitamente fallaci) considerazioni sulla “diversità” e/o “superiorità” tra “noi” e “loro” (o, inversamente, “anche loro lo fanno/farebbero con noi, dobbiamo difenderci”); ora saranno considerazioni sul fatto che “sarebbe bello se…ma è impossibile” (“dove metteremo le mucche?”, “su chi sperimenteremo?”, “anche l’agricoltura è violenza” ecc.); ora sarà la necessità di non farsi prendere dall’emozione e invece “ragionare seriamente”. La solfa suona ormai talmente poco credibile che recentemente il New York Times ha indetto una grande consultazione alla ricerca delle “ragioni etiche per mangiare carne”, a dimostrazione che la nostra caparbia testimonianza comincia ad intaccare il muro dell’indifferenza socialmente prodotta e delle sue certezze automatiche ed auto-assolutorie.
6. Ogni attivista o simpatizzante per i diritti animali ha da tempo fatto sulla propria pelle l’esperienza di come la teriofobia sia pervadente, quasi asfissiante. All’inizio questa esperienza è stata vissuta in forma individuale, generando necessariamente sensazioni di solitudine e sconforto, della serie “loro” non “mi” capiscono. Aggregandosi ad altri simpatizzanti verso la sofferenza animale, si è poi inevitabilmente tentato di uscire dal senso di isolamento attraverso una coscienza collettiva: la propria scelta ha così guadagnato i contorni netti di una scelta condivisa e quindi non più tanto assurda. Il “noi” ha sostituito l’“io” della pratica individuale rafforzandosi nella forma di uno “stile di vita” condiviso[10]. Ciò ha avuto un effetto distorcente anche sul modo in cui la teriofobia è stata teorizzata all’interno del movimento di liberazione animale. Si è infatti parlato di “vegefobia” come della “discriminazione” di cui sarebbero fatti oggetto i veg*ani e del modo in cui tale discriminazione sia, in realtà, una mossa per mettere a tacere ancora una volta la voce degli animali, rappresentati metonimicamente da chi sceglie di non mangiarli. Con questo mi sembra si sia detto al tempo stesso troppo e troppo poco.
Troppo perché, come è stato da più parti obiettato a chi denunciava la “vegefobia”, è particolarmente infelice parlare di “discriminazione” per il fatto di essere talvolta derisi a tavola o perché la mensa scolastica non offre pietanze adeguate. Si possono raccogliere tutte le testimonianze di questo mondo o tacciare l’intero sistema mediatico di atteggiamenti derisori o persecutori nei confronti dei veg*ani, ciò non cambia il dato di partenza: a fronte della violenza e del sangue che storicamente grondano dalla parola “discriminazione” è un chiaro atto di formalizzazione e di spoliticizzazione definire “discriminatori” questo tipo di fenomeni[11]. La violenza e il sangue, si dirà, non saranno quelli dei veg*ani ma sono quelli degli animali. Certo, solo che il problema di questi ultimi non è il loro essere “discriminati” (come vuole l’antispecismo che prende le mosse da Singer), bensì il loro essere “sfruttati”. Il discorso sulla vegefobia non solo non aiuta a chiarire la differenza e ad articolare il rapporto tra discriminazione e sfruttamento, ma addirittura confonde ancora di più le cose, parlando della discriminazione degli animali attraverso la discriminazione degli umani. Si tratta di un pericoloso cedimento all’ideologia liberale che ha portato alla pratica del politically correct: quest’ultima sublima la lotta materiale di gruppi oppressi dentro specifici sistemi di potere nell’ecumenico riconoscimento della diversità a livello discorsivo, attraverso pratiche ben oleate e amministrate di cooptazione delle classi dirigenti di quegli stessi gruppi e il riconoscimento di diritti formali che non intaccano gli interessi materiali che profittano della loro oppressione. A chiunque è oggi permesso denunciare la “discriminazione” di cui è fatto oggetto in quanto membro di un gruppo X (religioso, etnico, di orientamento sessuale e ora…alimentare!), purché ciò non modifichi gli assetti di potere vigente. Inserendosi dentro questa logica sistemica, il discorso sulla “vegefobia” banalizza ciò che storicamente è sedimentato nella parola “discriminazione” accogliendone l’incarnazione liberale che alleggerisce e appiattisce i conflitti politici sterilizzandoli e armonizzandoli in conflitti di opinione.
Si potrebbe obiettare che in realtà il discorso sulla “vegefobia” è più radicale del discorso liberale perché tenta di dare voce al gruppo oppresso che è oggetto dello sfruttamento più feroce: a suo supporto è stato infatti elaborata la teoria della “negazione simbolica” degli animali attraverso la discriminazione dei veg*ani. In sostanza, denunciare la “vegefobia” è un modo per ricordare come sia la voce stessa degli animali uccisi ad essere silenziata attraverso la “discriminazione” dei veg*ani. Ma su questo versante del discorso la “vegefobia” dice invece troppo poco. Come abbiamo visto, infatti, non è il fatto di astenersi dal “mangiare carne” di per sé a provocare la reazione sarcastica, stizzita o autoritaria denunciata come “discriminatoria”. È il fatto di mostrare solidarietà con la vita animale (umana e non-umana) che costituisce l’architrave del sistema sociale vigente a far scattare il meccanismo difensivo che porta alla derisione o al linciaggio (per fortuna solo simbolico) di chi esercita quella solidarietà. La “vegefobia” non permette di spiegare il risentimento nei confronti di chi si oppone alla sperimentazione animale, di chi protesta contro una sfilata di pellicce o una sagra di animali. La teriofobia sì. Essa si radica nelle viscere nere dello specismo sociale e ne estrae la bile più violenta di fronte al gesto più gentile e allo sguardo più compassionevole. Questa l’assurda legge del contrappasso che va spiegata e lo si può fare solo collegando la genesi e la struttura della civiltà con la rimozione dell’animale e la conseguente paura che il suo ricordo suscita.
L’animalista, il veg*ano e, ancor di più, l’antispecista come testimoni di una vita irriducibile alla “normalità” dell’attuale sistema sociale e politico, producono con la loro semplice esistenza una crepa insopportabile nel Sé individuale e collettivo, nelle sue certezze, nelle sue priorità, nei suoi valori. Questo basta per far montare l’angoscia diffusa di “conti che non tornano”, di un senso di colpa che non riguarda solo il sacrificio degli animali non-umani ma anche di tutto ciò che dentro il soggetto è stato necessario cancellare o mettere a tacere perché la normalità potesse esercitarsi indisturbata a fronte di tanta violenza. La mortificazione dell’animale umano è il contrappunto alla messa a morte dell’animale non-umano. Chi anche solo dice di voler rifiutare tutto ciò risveglia una paura ancestrale, smisurata come tutto ciò che appare retrospettivamente alla memoria nello specchio deformante dell’infanzia.
****
Nota (2013)
Questo articolo ha ispirato una serie di piccate polemiche, per lo più capziose e strumentali ad interessi che poco hanno a che fare con la discussione teorica e la ricerca della verità. Sono stato costretto mio malgrado, dall’esagerazione e dal puntiglio ostentato che le ha caratterizzate, a rispondere a tali polemiche nei seguenti interventi:
Chi ha paura della teriofobia? Risposta ad una polemica infondata
I non-lettori intervistano Marco Maurizi
[1] S. Freud, L’avvenire di un’illusione in Id., Il disagio della civiltà e altri saggi, Bollati Boringhieri, Torino 19928, p. 155.
[2] Ho esposto in modo più dettagliato questi temi in M. Maurizi, Al di là della natura. Gli animali, il capitale e la libertà, Novalogos, Aprilia 2011.
[3] Th. W. Adorno – M. Horkheimer, Dialettica dell’illuminismo, Einaudi, Torino 1994, p. 50.
[4] A. Rivera, La bella, la bestia e l’umano. Sessismo e razzismo senza escludere lo specismo, Diesse, Roma 2010, p. 105.
[5] M. Bujok, “La resistenza contro lo sfruttamento animale. Riflessioni sul rapporto tra società razionale e liberazione animale a partire dalla Scuola di Francoforte”, in M. Filippi – F. Trasatti, L’albergo di Adamo. Gli animali, la questione animale e la filosofia, Mimesis, Milano 2010, p. 254.
[6] Ibid.
[7] F. Trasatti, La rimozione dell’animale, su «Liberazioni.org»
[8] Z: Bauman, Modernità e Olocausto, Il Mulino, Bologna 2010, p. 38.
[9] Th. W. Adorno, Minima moralia, Einaudi, Torino 1994, p. 35.
[10] Ho già denunciato altrove il rischio identitario di questo atteggiamento, soprattutto perché finisce per confondere la lotta contro un sistema sociale, economico e culturale – e dunque una scelta politica, cioè un’idea diversa di società – con la testimonianza individuale o al massimo di tanti individui che condividono la stessa scelta individuale – e dunque una scelta morale. In tal modo, si è confuso l’antispecismo con il veganismo, cioè l’idea alternativa al presente con una pratica individuale, invece di elaborare una strategia complessa e a lungo respiro che ci permetta non solo di essere gli ingranaggi fuori posto della meccanica sociale, ma anche la forza interna che smonta la mega-macchina per ricostruirla in modo non oppressivo e volgerla ad altri fini.
[11] In maniera non dissimile da coloro che parlano di “olocausto animale”, facendo così perdere ogni specificità storica e politica alla Shoah.
Comments
45 Responses to “Teriofobia”Trackbacks
Check out what others are saying...-
[…] o vegano. Mi ha fatto molto riflettere la discussione nata in seguito all’articolo “Teriofobia“, scritto da Marco Maurizi. Nei commenti, giustamente, alcuni (tra cui lo stesso Maurizi) […]
-
[…] davvero singolare che un testo che offre per 9/10 una teoria della paura dell’animale (umano e non-umano) nonché riproponga […]
-
[…] altrettanto. Marco Maurizi – poi non lo cito più – ha parlato a questo proposito di teriofobia come «caratteristica strutturale della civiltà». Che coinvolge tutti, dominanti e dominati: […]
-
[…] altrettanto. Marco Maurizi – poi non lo cito più – ha parlato a questo proposito di teriofobia come «caratteristica strutturale della civiltà». Che coinvolge tutti, dominanti e dominati: […]
-
[…] “Teriofobia” di Marco Maurizi, recentemente pubblicato su questa rivista, contiene nella sua seconda parte una […]
-
[…] Teriofobia di Marco Maurizi ha suscitato numerose critiche. Non mi riferisco al disappunto che esso ha […]
-
[…] Teriofobia di Marco Maurizi ha suscitato numerose critiche. Non mi riferisco al disappunto che esso ha […]
-
[…] precisione la genesi e la struttura di questa angoscia atavica. Cfr. M. Maurizi, Teriofobia, http://asinusnovus.wordpress.com/2012/05/02/teriofobia/. [4] A questo proposito mi permetto di rimandare al mio Teriofobia for dummies, […]




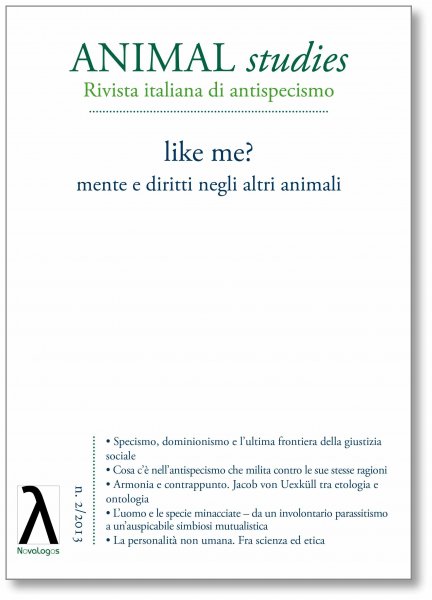
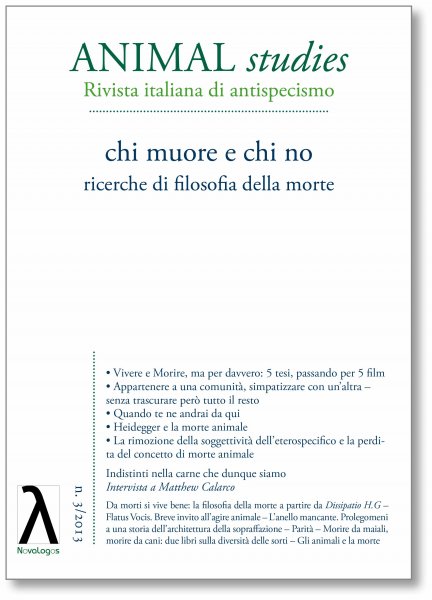
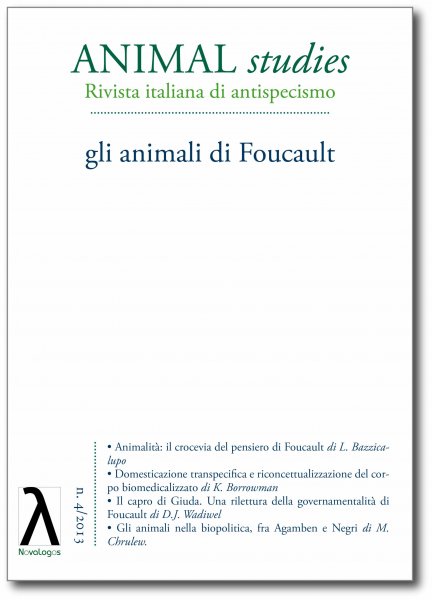


C’è anche un aspetto antropologico della teriofobia: manifestare paura per gli animali per dimostrare di aver superato lo stadio della rozzezza contadina ed essere diventati ‘civili’ (non accorgendosi di aspirare soltanto a diventare piccoloborghesi). Qui le ragazzine ostentano di aver paura delle galline, sì, delle galline, tra gli animali più innocui che si aggirano ancora per gli ultimi cortili di campagna rimasti.
Anche quest’articolo era necessario.
Ne ha di lavoro da fare l’antispecismo!
Bellissimo, soprattutto per gli incroci che svelano i meccanismi del potere
Argh, hai messo anche l’immagine di Ulisse! Io, alle arpie, preferisco la rabbia dolorosamente “addomesticata” di fronte ai proci:
“Il cuore gli latrava come una cagna”
“Sopporta, o cuore”
Una nota che basterebbe da sola a convincermi a cominciare a parlare di teriofobia.
(Rimani comunque un dannato guastafeste)
in effetti volevo mettere i porci ma non ho trovato un’immagine altrettanto suggestiva 🙂
Caro Marco, come sempre complimenti per i tuoi articoli. Sono però perplessa sul discorso che fai in merito alla vegefobia: ho conosciuto ultimamente diversi attivisti francesi, i quali hanno usato proprio questo termine spiegandomi che, nella ‘civilissima’ Francia, l’attitudine nei confronti di vegani e antispecisti sia, se possibile, assai meno conciliante che qui, nell’ignorantissima Italia. Là, a pochi kilometri giusto oltre il ‘confine’, essere vegani o antispecisti è davvero l’eccezione dell’eccezione: parlando di problemi pratici, è difficile trovare negozi di alimentari e prodotti veg*,mentre è la norma vedere apposti negli studi medici pannelli che spiegano come l’alimentazione carnea sia NECESSARIA…per non parlare di coloro che, ad esempio, volessero crescere dei figli* vegani, i quali devono tenere ben nascosto questo aspetto della propria vita, dissimulare l’alimentazione dei figli*… e che rischiano comunque vere e proprie persecuzioni da parte di dipendenti scolastici e medici in quanto genitori inadeguati, sorta di psicopatici con fissazioni settarie. Parlare di discriminazione non mi pare in questo caso inadeguato, poiché anche le discriminazioni più grandi non sono sempre piombate come una mannaia sulle vittime, ma si sono insinuate spesso con movenze subdole, con graduali limitazioni della libertà, come un veleno che somministrato ogni giorno arriva ad uccidere chi lo assume. E comunque le discriminazioni uccidono anche in maniera silenziosa o possono anche non uccidere ma privare la vita della dignità e delle opportunità (non erano discriminazioni i cartelli “non si affitta ai meridionali” che erano consueti qui al nord pochi decenni fa? E i negozi cche non servivano agli ebrei? Eppure non uccidevano, o almeno non direttamente, non subito!)A prescindere dalla situazione francese, della quale chiaramente non ho esperienza diretta, a me pare che, al momento e qui in italia, la vegefobia (termine forse non del tutto adeguato) o ‘antispecismofobia’ non sia ancora così sentito poiché la tenuta generale dello specismo, a discapito delle ‘bestie’ e dei folli che ne difendono le sorti è perlopiù salda. Non credo che la ‘reazione anticorpale’ all’antispecismo da parte dello status quo sarebbe così gentile se i numeri diventassero tali da costituire veramente una minaccia permanente, se non fossimo più così ‘isolabili’ e rinchiudibili nel recinto dei freaks.
Se guardiamo a quanto sta succedendo ad esempio intorno al caso di green hill, alla contemporanea esigenza sentita dai vivisettori di organizzare campagne pubblicitarie pro-sperimentazione, o addiritura di scrivere (dagli stati uniti) al senato italiano, in merito alle direttive nazionali sulla sperimentazione animale (che potrebbero costituire un pericoloso precedente), mi pare che, quando il fenomeno antispecista si concentra intorno ad un obbiettivo la ‘fobia’ specista, con qualsiasi prefisso, non tardi a mostrarsi. Ciò dà sicuramente il polso della minaccia che – finalmente – si comincia ad addensare sull’ecatombe specista, ma non metterei la mano sul fuoco in merito alla reazione che scatenerà. L’incendio della discriminazione più letale può essere appiccato dall’unione di tanti fiammiferi d’intolleranza, e mi pare che di questi siamo abbastanza circondati.
Interessante e bellissimo articolo.
Noto che tra i motivi più diffusi per cui certa gente manifesta la fobia nei confronti degli animali ci sono quelli legati all’igiene; gli animali sarebbero sporchi, porterebbero malattie, perdono peli, puzzano ecc.. Curioso come poi questa stessa gente non ha più nessun tipo di scrupolo quando invece se li trova dentro al piatto.
Di recente mi è proprio capitato di leggere questa affermazione in un blog (cattolico): “provo ribrezzo per ogni animale, tranne quelli che si finiscono nel mio piatto”. E infatti anche la religione ha contribuito moltissimo alla teriofobia: basti pensare al serpente associato alla tentazione di Satana (così come la donna che lo ascolta) e che ne diviene iconograficamente simbolo.
Anche la letteratura “laica” non è stata da meno: basti pensare ai tanti romanzi scritti sulla peste – con tutta l’enorme portata della sua valenza mortifera – veicolata dalle pulci dei topi (Il Decameron, uno su tutti). Il topo vive anche nelle fogne, certo. Ma le fogne non sono forse un prodotto dell’uomo?
Poi c’è il cinema, in cui gli animali sono sempre ridotti al rango di “mostri” o, al contrario, di creaturine antropormofizzate (basti pensare a come il notissimo “Lo Squalo” abbia erroneamente diffuso il concetto dell’aggressività di questo animale).
Ho riportato solo alcuni banali esempi, ma si potrebbe continuare per ore.
Insomma, ovunque ci giriamo la nostra cultura è intrisa di simboli volti a tramandare il concetto dell’alterità dell’animale rispetto a noi. Un’alterità da temere o da addomesticare.
Per non parlare poi di tutti i proverbi ed espressioni linguistiche che sin da quando nasciamo ci accompagnano e contribuiscono al formarsi dello specismo: “lurido come un maiale”, “cretina come una gallina”, “sei una bestia” ecc.
Per concludere: questo è un sito in cui si parla della vegefobia:
http://it.vegephobia.info/index.php?
Anche io non credo che sia un “fenomeno” da sottovalutare perché anche un’accennata derisione (come quella che ognuno di noi avrà subito migliaia di volte in circostanze sociali tipo pranzi, cene ecc.) mira a depotenziare la serietà dell’antispecismo. E quindi è a depotenziare il valore delle altre specie che in definitiva, sempre, si tende.
Anche non trovare una facile reperibilità di prodotti vegani è una forma di “discriminazione”, secondo me.
In molti paesi, tipo in Inghilterra, ogni ristorante, pub o locale ha anche sempre un menù vegetariano e almeno qualche piatto vegano, rigorosamente contrassegnato. Nel nostro paese le nostre legittime esigenze proprio non vengono prese in considerazione.
Un saluto. 🙂
Bravissimo.
Se posso aggiungere un commento a ulteriore rafforzamento di ciò che sostieni, trovo che la deriva “vegefobica” del movimento animalista sia a un tempo insultante e pericolosa.
Saprete senz’altro che già esiste da qualche anno il Veggie Pride, occasione nella quale i veg*ani possono sfilare, magari allegramente mascherati da carota, per protestare contro la discriminazione e reclamare uguali diritti. Ora, quando un veg*ano verrà picchiato brutalmente a causa delle sue preferenze alimentari (spero ovviamente che ciò non accada mai) l’uso del termine “discriminazione” potrà essere minimamente giustificato; fino ad allora, come giustamente sottolinei tu, mi sembra più che un altro un insulto a chi è o è stato nel passato discriminato per davvero.
Ma l’aspetto più preoccupante della deriva vegefobica, secondo me, è il rischio di trasformare la questione animale nella questione dei diritti degli animalisti. Questo a ben pensarci accade spesso anche a livello di singolo scambio di opinioni con qualche specista. Dopo un po’, la discussione tende quasi sempre a spostarsi dalla sofferenza animale alle vere o presunte pecche degli animalisti (con commenti tipo “in linea di principio potrei anche essere d’accordo con alcune delle istanze, ma non mi piacciono gli integralismi, voi siete talebani, aggressivi, ecc.), al che mi verrebbe sempre da chiedere all’interlocutore: “ma se anche fosse vero che tutti i singoli antispecisti sono aggressivi, talebani, integralisti, che cosa ha a che fare tutto ciò con la questione della sofferenza degli animali? (Ai quali, per inciso, degli animalisti importa sicuramente molto meno di quanto importi ai loro detrattori). Per capire l’assurdità, è come se una persona si formasse un’opinione sull’esistenza di Dio sulla base di quanto sono più o meno simpatici credenti e non credenti.
Per non parlare dello sconforto che prende ogni qual volta si obietta al veg*ano sulla base di un malinteso principio liberale di rispetto delle scelte di vita altrui (sostanzialmente in base all’argomento “ognuno sia libero di mangiare ciò che vuole senza pretendere di imporre ad altri le proprie preferenze”, affermazione che di solito viene accompagnata dal paragone tra la scelta vegana e la scelta di non fumare, di non bere alcolici, e via dicendo). Chi obietta in questo modo alla scelta di non nutrirsi di animali è come se, per usare un esempio che mi sembra efficace, non riuscisse a vedere un enorme elefante rosa in una stanza vuota.
L’enorme elefante rosa è, fuor di metafora, il fatto che miliardi di esseri senzienti devono venire ammazzati (in genere dopo avere trascorso una non-vita in condizioni abominevoli) affinché le persone carnivore possano esercitare la loro “libera” scelta alimentare.
Purtroppo moltissime persone non sembrano ancora in grado di vedere l’elefante rosa nella stanza vuota (chiunque si trovi a discutere con carnivori presi a caso dalla popolazione generale lo sa molto bene). Notate che se le persone completassero il loro ragionamento affermando che per loro gli animali non-umani non hanno status morale – magari argomentando questa posizione – e che quindi la scelta carnivora NON ha implicazioni etiche sarebbe già un enorme passo in avanti, perché dimostrerebbe che l’elefante almeno l’hanno visto. Non vederlo significa invece pensare che la scelta di mangiare carne equivalga a quella di bere del buon vino (come anche il titolo di un recente libro tristemente dimostra).
La deriva vegefobica, a mio avviso, non fa che rafforzare questo enorme fraintendimento. Tra un po’ vedremo veggie pride organizzati in ogni città e firmeremo petizioni per chiedere l’inserimento di menu vegani nelle mense aziendali (richiesta che per inciso, aumenterà un altro equivoco: quello di vedere le restrizioni alimentari auto-imposte del veg*ano assimilabili a quelle dell’ebreo che mangia kosher, del cattolico che non mangia cerne il venerdì o del musulmano che non mangia maiale; altro paragone deleterio e fuorviante).
Alla fine di queste battaglie, otterremo forse i menu vegani, avremo i nostri ghetti (i ristoranti veg) e magari verremo anche chiamati “diversamente alimentanti” in ossequio al politically correct. E intanto gli animali verranno squartati come e più di prima.
Ma io non parlerei di “deriva vegefobica”. La vegefobia è solo un problema sollevato che, a mio avviso, esiste.
Non ha senso fare classifiche dei discriminati, ma se proprio vogliamo farle, è ovvio che neri e omosessuali si giocano la zona Champions e “noi” al massimo lottiamo per la salvezza.
Però discriminare non è solo pestare o escludere. Anche la micro emarginazione a cui è sottoposto quotidianamente un antispecista, guardato come un diverso potenzialmente pericoloso per lo stile di vita comune tradizionale, è una forma di discriminazione che crea anche disagi reali. Che so, metti che ti fidanzi con una che ti invita a pranzo dai suoi e loro scoprono che sei vegano, nella maggior parte delle volte penseranno che sei un pazzo e spereranno che vi lasciate, quando non faranno in modo di ostacolare la vostra relazione. Oppure avranno sempre quell’aria di diffidenza “in che mani sarà nostra figlia”, e sono piccole cose che alla lunga avvelenano le giornate e danneggiano un’esistenza.
E la vegefobia non riguarda certo solo i vegani, ma SOPRATTUTTO proprio gli animali: percependo te come minaccia al panino col prosciutto, si mira a difendere il diritto di ammazzare il maiale.
Poi siamo d’accordo sul fatto che non sia certo questa la questione prioritaria da affrontare per la liberazione animale. Ma, come dice il saggio, “tutto fa”.
non sono d’accordo sdramma, la mia sensazione è proprio che la “vegefobia” “non fa”, anzi “disfa”. Non è solo questione di esagerare la “discriminazione” (che cmq è importante, questo discorso rischia di diventare una auto-vittimizzazione incompresibile all’esterno) è proprio che l’analisi del nostro ruolo nella società diventa atrocemente banale (e tipico di tutti i gruppi “minoritari”, come se noi fossimo un “gruppo” tra gli altri, classica mentalità da politically correct!). Invece le implicazioni tra lo sfruttamento animale e il nostro ruolo “eccentrico” (e quindi, certo, “difficile”) nella società umana sono molto più profonde e ho cercato di delinearne alcuni aspetti. E questo è confermato proprio dal fatto che, per superare l’obiezione dell’eccesso di vittimizzazione, si è tentato di rendere la “vegefobia” più “intelligente” sottolienando il rapporto tra la nostra “discriminazione” e la morte degli animali…Ma se anche fosse così, il nesso che viene trovato è superficiale…i “cattivi” carnivori che sbeffeggiano i “bravi” veg*ani per “non vedere” la morte degli animali. Basta, co ‘sta roba! Da gruppi “politici” come quelli che hanno inventato questa storia della “vegefobia” mi aspetto qualcosa di più.
“Che so, metti che ti fidanzi con una che ti invita a pranzo dai suoi e loro scoprono che sei vegano, nella maggior parte delle volte penseranno che sei un pazzo e spereranno che vi lasciate, quando non faranno in modo di ostacolare la vostra relazione. Oppure avranno sempre quell’aria di diffidenza “in che mani sarà nostra figlia”, e sono piccole cose che alla lunga avvelenano le giornate e danneggiano un’esistenza.”
Sdrammaturgo, scusa se sdrammatizzo, ma che stai a di’? 🙂
Scherzi e battute a parte, davvero pensi che i genitori di una ragazza che si fidanza con un vegano arriverebbero addirittura a cercare di ostacolare la relazione? A me sembra che questo che tu dipingi sia uno scenario un po’ eccessivo, ma magari mi sbaglio e allora la discriminazione anti-vegana diventerà un problema più serio di quanto io ritenga.
In ogni caso, non vorrei dare l’impressione di negare che tale discriminazione esista. Esiste eccome, e come molti di voi la sperimento quotidianamente sulla mia pelle; dico solo che – per ora- ritengo che molti di noi abbiano per fortuna le spalle sufficientemente robuste per fare spallucce di fronte a qualche battuta sarcastica nonché i mezzi intellettuali per poter rispondere con altrettanto sarcasmo.
Io intravedo il pericolo che la discriminazione anti-vegana diventi IL problema centrale rispetto al quale ancora una volta gli animali rimangono ai margini. Forse dovremmo trovare il modo di reagire alla discriminazione in modo costruttivo, non subendola ma anzi usandola come leva positiva per incanalare e dirigere lo sguardo di scherno del carnivoro in direzione dell’immenso dolore rimosso e sommerso (l’elefante rosa del mio esempio). Se mi chiedi in che modo pratico conseguire questo obiettivo, francamente non lo so.
“Scherzi e battute a parte, davvero pensi che i genitori di una ragazza che si fidanza con un vegano arriverebbero addirittura a cercare di ostacolare la relazione?”: sei stata fortunata a non nascere e a non crescere negli ambienti in cui sono nato e cresciuto io 😀
per tacere di quelli in cui sono cresciuto io! http://www.youtube.com/watch?v=X1QdJTt7BCY 😀
Buon vecchio centocellaro redento 😀
Nei miei ambienti c’era mia madre ad esempio che quando anni fa mi capitava di parlare del veganismo in presenza di mia sorella, dieci anni più piccola di me, diceva: “Non parlare di certe cose davanti a tua sorella!”. O una mia amica che quando smise di mangiare carne, il padre tuonò: “Non voglio vegetariani in casa mia!”.
Le persone fragili che vorrebbero diventare vegan ma non lo fanno per il timore di essere escluse sono mooolte più di quanto si pensi. Certo, evidentemente è fragile anche il loro amore per gli animali, ma ogni vegano in meno è un contributo in più allo sfruttamento animale.
Penso ad un ragazzino insicuro che vorrebbe abbracciare la causa antispecista e dare il proprio contributo al sogno della liberazione e poi entra su Facebook e trova “Vegano stammi lontano”.
Ecco in che senso la vegefobia è un problema che tocca principalmente gli animali, in quanto mira a far avere meno persone possibile che si occupino della causa, e chi ci rimette sono proprio gli animali.
Siamo abituati ad occuparci sempre di tematiche universali e ci dimentichiamo che la vita è fatta soprattutto delle chiacchiere al bar mentre si prende un amaro con un amico. Alla fine, i minuscoli, insignificanti aspetti della quotidianità più banale finiscono per fare la differenza.
C’è da aggiungere anche che non ho mai sentito nessuno parlare di vegefobia come uno dei problemi principali, ma sempre come un argomento minore e marginale. Ecco perché dico che non parlerei di deriva vegefobica.
E a tutto questo ho pensato mentre stavo facendo dorsali e tricipiti in palestra circondato probabilmente da vegefobici 😀
Quanti bei commenti, sono contento! 🙂
Attenzione, io non ho detto che non esistano difficoltà personali prodotte dal sistema vigente ai danni dei veg*ani. Sono però convinto che parlare di “vegefobia” sia fuorviante. Anzitutto perché, come ha osservato anche feminoska, più che altro si tratta di “antispecismofobia” (tanto è vero, come dico nell’articolo, che veniamo derisi e osteggiati anche quando protestiamo contro la vivisezione o gli zoo in cui l’aliemntazione non c’entra proprio nulla) e, io sostengo che l’antispecismofobia sia solo un’aspetto della teriofobia. E quindi quello che voi chiamate “vegefobia” secondo me andrebbe chiamato “teriofobia”. Ci tengo molto a questo non perché il termine l’abbia creato io (a differenza di “vegefobia” che è pure un brutto neologismo, “teriofobia” esiste da lunga data…) ma perché mi sembra che renda meglio e a livello più complesso il problema dell’odio inconscio (1) contro gli animali, (2) contro chi li difende, nonché (3) contro l’animale umano “ingabbiato”, scusate la semplificazione, nella civilità (quest’ultimo aspetto secondo me è centrale: è proprio la sensazione che chi difende gli animali metta a repentaglio il nostro intero mondo, anche interiore, anche il nostro modo di percepire e vivere gli animali che produce quell’astio altrimenti immotivato…come scrive Rita noi cresciamo educati al disprezzo dell’animale e dell’animalità, dello sporco e dell’istinto ecc.ecc.). In effetti anche la teoria che ho presentato non è granché originale, è una semplice applicazione delle intuizioni di Adorno e Horkheimer alla situazione attuale. Ma mi sembra che metta insieme questi tre aspetti molto meglio della “vegefobia”.
In secondo luogo, come dice Maria Giovanna, il problema della “vegefobia” è che si concentra sulla “discriminazione” degli animalisti e questo ha un duplice effetto che ho definito “spoliticizzante”. Da un lato, fa sì che, come dice Maria Giovanna, ci si concentri sui “diritti degli animalisti”, invece che sul problema della sofferenza animale. Non so se, come dice feminoska, tanti atti di discriminazione “minori” possano portare ad una sitauzione repressiva più grande. So però che sicurmaente non si combatte la repressione con la richiesta di diritti, bensì con l’analisi dei rapporti di forza e la rottura dei meccanismi profondi del sistema. Qui c’è il cedimento, secondo me, dell’animalismo ad una visione neoliberale, cioè l’amministrazione del conflitto DENTRO le logiche di sistema.
Dall’altro lato, e questo consegue al primo punto, anche quando la “vegefobia” viene intesa in modo più “raffinato” come negazione simbolica della sofferenza animale, mi pare che si perda di vista il rapporto che lega la repressione dell’antispecismo e l’oppressione deglia animali non-umani (la “repressione” dell’animale umano attraverso la cultura patriarcale, bellicista, adultocentrica e classista, poi, viene completamente dimenticata). Si dice che siamo discriminati perché discrminiamo gli animali. Ma parlare di “discrminiazione” qui è proprio deleterio perché occulta il problema vero: la repressione degli animali e dell’animalità umana (cioè rispetto a quanto detto sopra: vede il problema 2 ma lascia intatti l’1 e il 3) e, per di più, rende difficile vedere la soluzione…che dev’essere politica! Di nuovo, i casi di sofferenza individuale potranno anche essere reali e intensi ma, per tornare al paragone con ben altre discriminazioni, la “discriminazione” contro i neri o le donne non è l’effetto di singole discriminazioni, bensì una qualità sistemica che si fonda sull’oppressione! E la lotta contro la discriminazione è stata indebolita e messa fuori corso quando invece di essere politica (cioè lotta contro un sistema economico e politico) è diventata culturale e morale (cioè lotta per una cultura “rispettosa” delle minoranza, politically correct ecc.)
In sostanza penso che quanto di vero c’è nel concetto di “vegefobia” sia espresso al meglio da una teoria della “teriofobia”. Senza neologismi e senza derive “moraliste”…
Un amico scrive a proposito dell’articolo:
“Solo una nota a margine: nell’odio verso i vegani-vegetariani-animalisti (dal basso) gioca un ruolo anche l’antagonismo di classe rovesciato, molto diffuso negli Usa ma anche qui, per cui la sinistra è identificata con un ceto borghese privilegiato, che può permettersi un’alimentazione diversa (anche perché, sempre secondo questa rappresentazione distorta, non svolge lavori che richiedono l’apporto proteico della carne).
Sono stronzate, ma sul piano ideologico e simbolico (e quindi politico) hanno la loro importanza. Tanto che gli agricoltori poveri del sud, agganciati con questi discorsi (hardwokingman cristiano contro liberalmangiacaroteabortista), votano contro i loro interessi materiali, sostenendo politici repubblicani le cui politiche fiscali favoriscono le grandi corporation agricole che stanno facendo piazza pulita di tutti i piccoli produttori.”
Ancora sulla vegefobia.
Io mi trovo d’accordo – e si capiva dal mio primo commento – con Sdrammy. Ovviamente comprendo ciò che vogliono dire Marco e Maria Giovanna, ossia che ponendo l’attenzione su noi antispecisti in quanto persone che trovano ostacoli da parte della società si rischia di spostare l’attenzione su noi anziché sulle vere vittime che sono gli animali e infatti si deve stare bene attenti a far passare il messaggio che le nostre richieste non devono valere per noi, ma per gli animali, di cui noi ci facciamo portavoce e per cui presentiamo determinate istanze. La gente deve capire che noi per noi non chiediamo niente. E questo, a mio avviso, ci differenzia all’istante dalle altre “minoranze” cui rischieremmo di essere accostati perché siamo l’unica “minoranza” a non chiedere nulla per sé stessa, ma per altri. Questo è un punto fondamentale.
Il rischio che intravede Giovanna secondo cui “alla fine di queste battaglie, otterremo forse i menu vegani, avremo i nostri ghetti (i ristoranti veg) e magari verremo anche chiamati “diversamente alimentanti” in ossequio al politically correct” secondo me non può sussistere perché a noi del ristorante vegano importa fino ad un certo punto, ma quel che importa davvero è vedere gli animali liberi. E questo non può non essere evidente a tutti.
In realtà ciò che noi dovremmo contestare è il fatto che i nostri detrattori (coloro che ci fanno passare per matti, per fanatici, per patosensibili o, al contrario, per insensibili verso la nostra stessa specie poiché preferiremmo gli animali e così via), quando ci accusano, in maniera scorretta e tendenziosa, eludono, con lo scopo di rimuoverlo – se poi sia questo atteggiamento cosciente o meno non saprei – il vero oggetto della questione – lo sfruttamento e la sofferenza degli animali – depotenziando ed indebolendo il soggetto che sta cercando di porlo all’attenzione.
Facendo passare noi per matti ovviamente viene delegittimato il nostro argomento.
Mi torna in mente la discussione su Minima et Moralia in cui nemmeno una volta da parte di chi attaccava è stata fatta menzione della sofferenza degli animali, mentre tante energie sono state spese per denigrare noi antispecisti e l’antispecismo tout court.
Quindi la discriminazione di cui noi saremmo oggetto va intesa e combattuta in questo senso: cercando di riportare l’attenzione sugli animali. Non si può negare che vi sia però. Né, secondo me, va sottovalutata.
Concordo poi con un’altra osservazione che ha fatto Sdrammy: molti adolescenti, ma anche ragazzi più grandi che vivono ancora con i genitori trovano veri e propri ostacoli in famiglia a diventare vegani o anche solo vegetariani.
Confermo, ma solo come aneddoto “folcloristico”, che persino a casa mia quando ho riferito che sarei diventata vegetariana, mi sono sentita rispondere: “questa è una mania che ti ha attaccato il tuo fidanzato”. 😀
Infatti ora non oso dire che sono diventata vegana.
L’unica maniera per far fronte a questi atteggiamenti di “discriminazione”, secondo me, è l’informazione.
Bisogna però lottare quando si manifestano perché se invece rispondiamo con un’alzatina di spalle dicendo a noi stessi che i problemi veri sono altri (pure se lo sono, cioè non sto negando che rispetto alla vera battaglia che stiamo combattendo, la battutina sarcastica in fondo sia poca cosa), rischiamo di lasciare un’arma in mano “all’avversario”, che è quella di eludere la sofferenza animale deviando l’attenzione su di noi.
Ripeto, non siamo noi che parlando di discriminazione stiamo spostando il problema su di noi, ma, evidenzionandola, stiamo invece cercando di ricondurre l’attenzione là dove deve essere focalizzata: nella gabbie degli animali.
Sembra un discorso contorto, ma non lo è affatto. 😉
mi sembra però che non ci capiamo. Io non contesto quello che dite, dico che la “vegefobia” (come teoria e come concetto-espressione) non è sufficiente ed è anzi fuorviante proprio rispetto alle cose che denunciate e volete cambiare. Però basta mi arrendo!!! Tenetevela! 😀
E’ che nel tuo inconscio sei un vegefobico 🙂
Ma invece come nome non è male!
A me, m’è piaciuto quando l’ho scoperto 😀
Non temere Ma’, ho capito fin da subito quello che intendevi. A mia volta dico che teriofobia indica già una cosa diversa. Invece esiste pure proprio una paura verso chi difende gli animali. La riscontro ogni giorno. Quella dovrà pur essere chiamata in qualche modo. A quella è stato dato un nome, magari un po’ parossistico, ma efficace. E poi a me i parossismi me so’ sempre piaciuti.
Io ne sono venuta per la prima volta a conoscenza grazie al tuo blog, scorrendo la lista dei siti ed altri blog che segui. 😉
Ciò che si chiama: propagazione dell’informazione. 🙂
Caro Marco, leggendo il pezzo (che nella prima parte è anche piuttosto interessante, ma che sembra avere nella sua prima parte soltanto un’introduzione al vero obiettivo dell’argomentazione, e cioè la vegefobia) si ha l’impressione che tu non sappia di cosa parli. Ma è un’impressione, non posso crederci davvero 🙂 Non è mai menzionata alcuna fonte sul concetto di vegefobia, inspiegabilmente, e ci hanno dovuto pensare altr* che hanno poi commentato il testo qui sopra. Addirittura mi è sembrato di notare che esistono diverse versioni del concetto, una proposta da chi ha coniato il neologismo o lo ha diffuso in Italia, ed una – più superficiale – sostenuta non si capisce bene da chi. E su questa seconda sarei curioso. Sulla prima, che mi sembra quella più interessante dato che è articolata (certo non a sufficienza), varrebbe la pena spendere due parole in più, oltre a quanto già molto ben detto da Feminoska, Sdrammaturgo e Rita. Un primo punto che mi ha impressionato è che sembri collegare la visione del veganismo come “stile di vita” (e la strategia maggioritaria in ambito animalista della conversione individuale al veganismo) ad alcuni “difetti” del concetto di vegefobia. Come tu ben sai, in Italia le (poche) persone che hanno insistito sulla vegefobia sono anche le (poche) persone che hanno insistito sulla critica al veganismo come “stile di vita”. Addirittura, tanto per fare nomi, c’è un’attivista per gli animali che ha scritto due testi molto chiari su entrambi i temi, aprendo sostanzialmente per prima il dibattito su di essi. Quello sulla vegefobia lo trovi qui: http://it.vegephobia.info/index.php?post/2009/12/01/Vegefobia
Quello sullo stile di vita, qui: http://www.veggiepride.it/index.php/documenti/54-diffondere-lo-stile-di-vita-vegan-una-critica
Ora, nè tu nè io – penso – crediamo che Antonella sia schizofrenica 🙂
Ma ovviamente questo non basta. La domanda è: che cosa c’entrano le due cose? Credo che se leggerai quei due testi, e le altre poche cose scritte su questi due temi, vedrai che la denuncia della vegefobia ha una connotazione fortemente influenzata dalla scelta di NON abbracciare l’idea del veganismo come stile di vita o di consumo, ma – al contrario – come atto politico. Non solo: è proprio in virtù della scelta di un modello non identitario di vegetarismo che è nata la critica della vegefobia.
Sarebbero tantissime le critiche al concetto di vegefobia che potrebbero essere rigettate semplicemente rimandando ai testi già esistenti: concentrarsi sulla richiesta di diritti, esagerare il problema, farne la questione cardine, non ammettere che esistano forme di “fobia” più ampie come l'”antispecismofobia” o la “teriofobia”, ecc.. Ma, appunto, rimando ai testi, basta leggere.
Mi hanno impressionato molto sia i lucidi esempi di sdrammaturgo, sia il fatto che dipingi la vegefobia con le parole “il fatto di essere talvolta derisi a tavola”. E’ ovvio che se prendiamo un singolo aspetto, possiamo sminuire a piacere la portata del fenomeno. Non solo, anche considerando il singolo aspetto, e considerando che i pasti al giorno sono 3-4, io non lo sottovaluterei comunque, almeno per rispetto di quelli che si trovano costantemente in certi ambienti. Di fronte alle discriminazioni, dobbiamo sempre stare attenti al nostro punto di vista individuale, perchè ci sono posizioni sociali differenti che si intersecano con la discriminazione: non è uguale essere ricchi o poveri di fronte alla vegefobia, non è uguale essere maschi o femmine, essere capi o impiegati, essere colti o ignoranti, avere o non avere figli, ecc.. Proprio come non è uguale, per es., per un(‘)omosessuale, essere ricco, povero, maschio, femmmina, ecc.. Non credo di dover spiegare in dettaglio questa cosa, è quasi banale.
La cosa interessante, però, credo non sia tanto il fatto che “vegefobia” dice troppo, perchè semplicemente non è vero (a meno che non ti riferisci a non so quali accezioni del termine o testi), ma che dice poco. In effetti, dice poco. Attenzione, però. Io diffido sempre dell’insistenza tipica dell’ambiente animalista sulla vivisezione, le pellicce, i circhi, ecc.. Non perchè non si tratti di problemi importanti. Soltanto che, a volte, pur di non parlare di carne, latte e uova, è più facile parlare di altro. La “fobia” nei confronti delle prese di posizione contro la vivisezione o le pellicce, in effetti, esiste. Ma – non per caso, credo – è un fenomeno molto meno virulento della vegefobia. Perchè non per caso? Probabilmente, essendo il mangiar carne il tabù più grande nell’ambito della questione animale, ed essendo questo il campo di sfruttamento più strutturato e numericamente più consistente (oltre il 99% degli animali uccisi sono uccisi per il cibo, tanto per dire), chi lo contesta nella pratica viene visto come maggiormente pericoloso. E probabilmente a noi stessi vengono le vertigini. Ecco perchè la vegefobia viene interiorizzata anche da noi veg, come ben esemplificato sopra, molto più dell’antivivisezionismofobia, per es..
Ad ogni modo, tutto ciò non significa che la parola “vegefobia” sia la migliore possibile. Si potrebbe organizzare una manifestazione in cui si denuncia la “teriofobia”, perchè no? Io sono convinto che la maggiorparte delle persone si sentirebbe, in buona sostanza, di andare a denunciare comunque la vegefobia, perchè è quella che – consapevolmente o meno – gli antispecisti subiscono e sentono di più. Ma forse sbaglio, e quel “di più” che il termine teriofobia veicola (ma attenzione: altri potrebbero prendere il termine, farne una caricatura, e dipingerlo come dannoso alla causa) potrebbe essere un buon contributo alla “causa”. A livello di elaborazione concettuale, mi pare che lo sia, del resto.
p.s.: Maria Giovanna, la manifestazione in cui di solito la gente va vestita da carotina è la Veggie Pride Parade, che non ha nulla a che fare con il Veggie Pride, corteo in cui i veg manifestano per gli animali e contro la vegefobia (magari qualche carotina gigante ci sarà, ma di solito si vede ben altro), non facciamo errori così grossolani, altrimenti pensiamo di parlare di mele e invece parliamo di pere 😉
Marco, perché non sistemi un po’ questo commento così lo pubblico come post per stimolare un po’ di dibattito?
scusate se non intervengo, ma per continuare la discussione potrebbe essere interessante ascoltare questa trasmissione in cui io, Marco Reggio, Sca e Antonella discutevemo proprio di queste cose: http://www.radiohinterland.com/files/registrazioni/Anthropos/veggiepride/veggie_pride.mp3
Ciao Marco!
Questo si chiama processo alle intenzioni! 🙂 In realtà mi sono convinto a malincuore ad aggiungere la “seconda” parte (che poi è solo l’ultimo, brevissimo, paragrafo!!) perché esplicita cose implicite nella prima. E l’ho fatto, questo sì, solo perché ho visto che Serena (colpa sua, quindi! :D) era stata attratta dal discorso “vegefobia” e siccome io e lei condividiamo le premesse di critica della civiltà che fanno parte della prima parte di questo testo, volevo chiarire (a me e a lei, e, poi, certo a chi ne fosse interessato) perché uno che fa un discorso di questo tipo, con un impatto politico, non può parlare di “vegefobia”.
No no io sostengo che le due concezioni, quella superficiale-liberale (discorso sulla “discriminazione”), e quella più seria-“politica” (discorso sulla “negazione simbolica”) si sostengono a vicenda nella visione dei filo-vegefobia…anche se ho sentito sostenere anche il discorso solo superficiale, ma come vedi bene non ho affatto usato questo fatto come argomento “contro”. Mi sembra di aver spiegato abbastanza bene nel testo e nelle risposte ai commenti sopra perché quel discorso mi sembra confusivo e “apolitico”.
Ma tu sai benissimo che io contesto che chiunque insista ancora a parlare di “veganismo” invece che di “antispecismo” stia facendo un discorso politico. Su questo dissentiamo profondamente per te è “politica” ciò che io considero mera estensione di un atteggiamento individuale…Quello che per te è l’antispecismo politico, per me è il fatto che alcuni veg*ani, oltre ad essere veg*ani, hanno anche coscienza politica ma non riescono ad averla in quanto veg*ani e non riescono nemmeno a superare questo dissidio. E la “vegefobia” è proprio l’emblema di questa schizofrenia. Con questo non voglio convincerti, hai già letto le cose che scritto sull’argomento e non serve ripeterle male in poche righe, voglio solo chiarirti perché ho scritto certe cose ben sapendo che dietro alcune di queste posizioni ci sono persone validissime, intelligentissime e politicissime come te. Che però si “identificano” in quanto veg*ani e fanno di questa cosa il punto di partenza (invece che il punto di arrivo) del proprio percorso “politico”, cosa che io appunto non faccio 🙂
Anzitutto devo dire che speravo di essere stato attento a non voler “minimizzare” o a mia volta “ridicolizzare” la “vegefobia”. E dunque ho cercato di darne una visione seria e articolata della cosa…da nessuna parte la mia critica si fonda sull'”esagerazione” e la questione dei diritti e della centralità dell’alimentazione mi sembra sia correttametne argomentata (sbagli quando dici che ho riddotto la vegefobia al “fatto di essere talvolta derisi a tavola”…checché tu ne pensi ho letto i testi sulla vegefobia PRIMA che in Italia arrivasse il VP 🙂 e anche dopo, nonostante fossi scettico sulla cosa, ho letto delle cose…ammetto di non aver letto però il secondo testo di Antonella che hai postato che leggerò quanto prima con interesse). Mi fa però sorridere il fatto che tutte queste cose che tu ESCLUDI dal concetto di “vegefobia” siano invece ben presenti in tutti coloro (a parte te e Antonella e chissà chi) che mi hanno parlato di “vegefobia” (leggi anche i commenti sopra!). Dunque delle due l’una: ho sono stato terribilmente sfigato io, oppure qualche dubbio sull’efficacia della teorizzazione “vegefobica” io me lo farei venire. Certo se la “vegefobia” fosse già la “teriofobia”, te lo dico sinceramente, non avrei sentito il bisogno di scrivere quello che ho scritto. Tuttavia, non mi risulta da nessuna parte che la “vegefobia” sia una critica alla civiltà, all’opposizione strutturale umano/non-umano in termini sociali e psicologici, che riguardi lo sfruttamento in generale degli animali e non solo la questione “carne” che tu/voi, mi pare evidente, considerate proprio “la questione cardine”:
Vedi? 🙂
“Pur di non parlare di carne”. Questa è la mentalità degli argomenti-indiretti e sai cosa ne penso.
Ma insomma vuoi dire che quando parlate di “discriminazione” non state parlando di “discriminazione”? Perché allo avresti perfettamente ragione. Il problema della deriva liberale e privatistica, spoliticizzante del discorso sulla “discriminazione” è un problema NON esclusivo della “vegefobia” ma di TUTTI i movimenti di liberazione che sull’onda del “personale è politico”/”riflusso” sono passati negli anni 80 dal discorso propriamente politico alla neo-lingua del politically correct. Come sai io approccio la cosa da un altro punto di vista, per me gli animali NON sono discrminiati (bensì sfruttati) e dunque sulla discriminazione anche dei veg*ani non penso abbia molto senso parlare. Non che non esista (l’avrò detto non so quante volte) ma è irrilevante dal punto di vista che per me è propriametne politico cioè che fa uscire l’animalismo dall’essere dei veg*ani con interessi politici e li fa pensare la questione animale come in sè politica. Senza ribadire, di nuovo, che io e te abbiamo idee diverse su cosa sia “politica”.
eh no, carissimo, qui sono io che ti dico che stai facendo della tua esperienza soggettiva una misura oggettiva del problema. Io personalmente gli attacchi più violenti li ho ricevuti proprio su altri argomenti. In quanto avversavo la vivisezione sono stato bollato come “fascista” e, qui su queste stesse pagine, mi hanno allegramente dato dell’idiota. I calci in culo (reali) li ho presi ad una sagra paesana in cui non si mangiava nulla di animale ma si torturava un animale per “rito” ecc. La “vegefobia” di queste cose qui non parla e non può parlare. Per questo dico che è insufficiente e (per i motivi sopra addotti: critica della civiltà, rimozione dell’animale interno/esterno, superamento dell’approccio individuale/liberale e comprensione/soluzione politica-collettiva del problema) fuoriviante.
E ovviamente ci verrei e fianco a fianco lotteremo per cose diverse 😉
Ma d’altronde non è sempre così?
Bellissimo l’articolo di Antonella sullo “stile di vita”. Riesce a dire benissimo cose che ho tentato invano di dire e mai con la stessa chiarezza e lucidità. Bravissima!
Rimane il problema della “schizofrenia”. Cominciamo però a dire che non vedo perché questo articolo dovrebbe costituire un argomento a favore della “vegefobia”…il fatto che sia stato pubblicato sul sito del VP non basta a mettere in relazione le due cose. E’ la questione “vegefobia” che dovrebbe essere argomentata in modo da rispondere alle critiche che ho posto, NON il fatto che CHI la sostiene sia “politicizzato”, critichi lo “stile di vita vegan” ecc.
A ciò aggiungo che ho qualche riserva sull’ultimo paragrafo che secondo me un po’ potrebbe spiegare la differenza tra la prospettiva che ho presentato qui e la questione “vegefobia”.
1) Cominciamo col dire che l’articolo, criticando (giustamente) la fissazione allo stile di vita vegan, nonché la sua “essenzializzazione”, arriva inevitabilmente a minare l’opposizione stessa tra veg*ani e non-veg*ani. Questo problema però viene accennato, poi considerato irrilevante e alla fine dimenticato, tornando ad affermare la necessità e/o l’inevitabilità di assumere uno stile di vita vegan. Sia chiaro: io sono d’accordo con la conclusione iniziale, ovvero che non esiste – e se esiste è politicamente irrilevante – un confine netto tra veg*ani e non-veg*ani. Però la conclusione mi lascia perplesso…infatti:
2) Quando, dopo aver problematizzato il veganismo, si cerca di “recuperarlo”, l’autrice afferma che la scelta veg è una conseguenza “logica”. Questo mi pare molto problematico. Perché se la scelta veg è “logica” lo è perché si è ragionato negli stessi termini di coloro che vengono accusati di assumere un stile di vita vegan, cioè sulla base dell’idea che diventando vegan si fa qualcosa per cambiare la condizione degli animali non-umani (dopo si dice anche che essere vegan “rappresenta un gesto di forte opposizione al sistema”…cosa che potrebbero dire tutti i vegan che sono stati criticati nelle righe precedenti!). Ma se non è così (e Antonella ha argomentato benissimo che NON è così!), allora la scelta non è tanto “logica”, quanto “emotiva”: si smette di mangiare carne perché non si sopporta l’idea che alla carne sia legata la sofferenza di un altro essere animale. Ma in quanto tale, cioè dettata da un istinto di compassione, la scelta vegan non può essere necessaria, perché è per definizione non-calcolabile e non prescrivibile.
Nota: quando dico che la scelta è emotiva e non logica non sto affatto svalutando l’aspetto emotivo a favore di quello razionale, tutt’altro. Anzi, non penso che possano esserci altri motivi per diventare vegan. Ma, questo il punto, se non si vuole che tale scelta diventi “arbitraria” e “non-vincolante” (appunto emotivo-soggettiva…chi empatizza, bene, chi no empatizza, pazienza), occorre impostare un discorso sulla “distribuzione sociale dell’empatia”, ovvero ciò che sopra ho chiamato con Bauman la “produzione sociale dell’indifferenza morale”. Ma questo discorso implica che si prenda in considerazione cosa produce (socialmente) la distanza emotiva dall’animale, cosa produca (socialmente) la gerarchia tra razionalità ed emotività, e dunque tutto il discorso sull’alienazione dell’uomo dalla propria animalità (ciò che nel testo ho sintetizzato prendendo a prestito da Trasatti l’espressione “rimozione dell’animale”).
3) Rimango poi perplesso quando leggo che in “numerose iniziative” la questione animale per come viene proposta “è già caratterizzata fortemente da una dimensione politica della rivendicazione”. Perché se da un lato è verissimo che tu e altri avete posto da tempo l’esigenza di parlare di un cambiamento “sociale” e di farlo in modo “pubblico”, cioè collettivo-condiviso, tuttavia:
a) visto che il pezzo si trova sul sito del VP immagino che l’autrice consideri “politica” una manifestazione in cui ci si deve presentare come “individui” piuttosto che come appartenenti ad un “gruppo”. Tra l’altro questi individui si riuniscono per protestare, tra le altre cose, proprio contro la “vegefobia”, visto che quest’ultima si è sempre accompagnata al VP e, per quanto ne so, è una delle sue componenti teoriche. Tutto questo, evidentemente, mi fa problema.
b) Così come mi fa problema l’idea con cui si conclude il pezzo: che gli animali “tornino ad essere protagonisti assoluti della rivendicazione animalista”. “Protagonisti assoluti” se lo intendo bene vuol dire anche “esclusivi” (e lo leggo così non a caso, ma perché il VP, sul cui sito compare l’articolo, sponsorizza l’argomentazione diretta, “proibendo” di articolare il rapporto tra oppressione animale e oppressione umana. Come si vede, il fatto che non l’abbia mai condiviso non è un caso e non è una novità di oggi ma la precisa conseguenza del modo in cui io credo vada impostata la questione animale…). La famosa questione degli “argomenti diretti” che io considero costitutivamente spoliticizzante. Come ho scritto altrove, infatti, l’argomentazione diretta produce (1) l’impossibilità di un’azione coordinata con altri gruppi politici umanisti. Per dirla in soldoni e banalizzando un po’: se io antispecista agisco e sono legittimato ad agire politicamente “solo” per gli animali (perché ogni considerazione “aggiuntiva” che leghi l’interesse umano a quello animale costituirebbe una “deviazione” illecita, un argomento “indiretto”), allora o la mia azione politica sarà settaria, oppure sarà trasversale. Cioè, in entrambi i casi, NON politica: moralismo “duro e puro” o interclassismo “per gli animali”. (2) Impedisce la costruzione di un soggetto politico in grado di definire obiettivi tattici e strategici che non abbiano immediatamntete a che fare con il destino di morte degli animali. Di nuovo: azione immediata, giustificata moralmente, dunque NON politica.
4) Infine, se questo è vero, mi sembra che ci sia il rischio di continuare ad impostare la questione in termini di “noi” (umani) e “loro” (animali), cioè rimane quella opposizione che bisogna non tanto cancellare quanto articolare storicamente e socialmente (come ho cercato di fare qui e altrove), in modo da dare respiro alla teorizzazione e alla pratica politica al di là dell’immediatezza che ci portiamo dietro come movimento: (a) a causa dei nostri papà (Singer & co) che ci hanno aperto la strada con una teoria e una prassi di tipo morale e in un orizzonte di pensiero liberale; (b) come figli di un’era in cui l’orizzonte di una trasformazione processuale delle istituzioni è stato da tempo abbandonato, prima come impossibile, poi come indesiderabile.
Sul fatto che gli animali siano non discriminati ma schiavi sono pienamente d’accordo. Ad essere discriminati sono quelli (ovviamente uso il genere maschile a comprendere anche il femminile, compiendo così la prima discriminazione della giornata, anche verso me stessa) che si oppongono a tale stato di cose. Codeste persone (o individui) tendono a non volersi cibare delle carni di altri, appartenenti a ad altre e varie specie. Generalmente parlando, si definiscono (o sono definiti) vegetariani – o veg*ani, a comprendere anche gli estremisti che, in paesi molto “civili” (se non altro per quanto concerne i diritti umani) vengono considerati una setta e rappresentati dai media come folli e orchi e streghe ammazzafigli nei peggiori dei casi, pazzerelli eccentrici da tollerare nei migliori.
È vero che non tutti i veg*ani lo sono per solidarietà con chi finisce messo in pentola; rimane però il gatto che anche autodefinendosi diversamente (antispecisti?), prendere pubblicamente posizione per la liberazione degli animali è un atto dalla profonda valenza politica. Se poi si ha l’ardire di organizzarsi in gruppi che rivendicano l’abolizione della carne, si compie un gesto fortemente politico, sostenuto anche dalla potenza simbolica della parola carne in tempi in cui si discute molto sulla perduta carica energetica e utopica di una politica desimbolizzata. Trovo che l’essere riuniti in un partito non sia oggi – e in questa fase storica per la condizione degli oppressi – necessariamente più politico di dare voce ad istanze e richieste, aprendo il dibattito dalla base come avviene quando si scende in piazza a manifestare o per le strade a discutere con chi dovrebbe pensare solo allo shopping ma si ferma a riflettere sull’abolizione della carne.
Il secondo punto che vorrei porre in luce è quello che riguarda il significato del termine “teriofobia” scelto a rappresentare, se ho ben capito, non l’atteggiamento discriminatorio che i difensori degli animali subiscono (e qui Maurizi storcerà il naso, in quanto sostiene non abbia senso parlare di difesa degli animali ma di tutti gli schivi sul pianeta terra) ma, l’atteggiamento storico-sociale ( e mitico?) nei confronti degli altri animali, riconosciuti non solo come “altro da sé” ma come un altro da sé da temere. Tralasciando il fatto, a mio giudizio non secondario, che la scelta di parlare di tabù richiederebbe un serio approfondimento del termine come concetto proposto dalla psicologia del profondo (soprattutto sapendo della sua portata di “rimozione” e quindi “spostamento”), preferisco rifarmi al pensiero di altri che – oltre Peter Singer – hanno riflettuto e scritto sul rapporto che intratteniamo con gli altri animali. Penso in particolare a Brian Luke, la cui tesi è che per la gran parte degli esseri umani la violenza sugli animali è profondamente problematica. E a Josephine Donovan, che teorizza l’etica del care, intesa non solo banalmente come “prendersi cura di” ma soprattutto come provare empatia con. Non è quindi scontato che la posizione interspecie sia necessariamente definita come una di paura e dominio: questa è la posizione da cui parte Singer. Per altri e altre le dinamiche di questo rapporto restano aperte e, se vogliamo, più ambigue. Trovo quindi che un termine come teriofobia le costringa invece irrimediabilmente entro una griglia di disprezzo e paura, concetto di base che Maurizi pare ben avere assimilato dalla lezione di Singer. Del medesimo Singer che per altro critica in quanto fondatore della una posizione etica rispetto alla questione animale, quindi individualistica – e quindi liberale, e per forza tout court non politica. O almeno non della politica come la intende Maurizi.
I veg*ani e le veg*ane sono discriminate in quanto non parlano solo per sé, come fanno altri gruppi; al contrario, vorrebbero che la loro filosofia (e no, non stiamo parlando di stile di vita!) valesse per tutti. Ora: non sono gli animali in sé a fare paura, ma gli umani che (individualmente e organizzati in gruppi) danno pubblicamente voce a ciò che ritengono debba essere universale. Ovvero: non uccidere e mangiare gli animali. Si esprimono quindi contro la libertà (individuale ma non solo) di cibarsi di quello che più aggrada. Cibarsi di schiavi è un fatto ideologico, perché legato alla libertà non solo dei singoli individui ma di intere organizzazioni sociali che ogni giorno, ogni istante rivendicano il loro diritto a farlo. È dunque anche vero l’opposto: prendere posizione contro l’ideologia dominante discrimina. Con il termine vegefobia si vuole porre in evidenza questa discriminazione, che come risultato nel mondano ha l’inibizione della presa di posizione per la liberazione delle altre specie.
Ringrazio Michela Pezzarini per questa articolata risposta. Temo di non essere d’accordo con quasi nulla di ciò che scrive, né col modo con cui sintetizza la mia posizione, né con la posizione che esprime e che mi sembra “la” posizione di coloro che sostengono la vegefobia. Sarò sintetico perché mi sembra di aver già risposto nell’articolo, nel diabbitto con altri qui sopra e in altri scritti a quanto obiettato:
Infatti è quello che ho sostenuto. Ma ho anche detto che il concetto di “discrminazione” è usato oggi (anche nei movimenti “umanisti” come l’anti-razzismo, l’anti-sessismo ecc.) su base “etica” e non politica e serve a decomprimere il conflitto sociale. Occorre smetterla di ragionare con le categorie offerte dal sistema a proprio uso e consumo.
Nota: questo è un tipico ragionamento ormai molto in voga negli ambienti “radicali” che è esso stesso effetto di un cedimento all’ideologia liberale. Trovo che la teoria politically correct del linguaggio sia quanto di peggio questo filone del pensiero politico ci abbia lasciato in eredità. Cancellare dal linguaggio le tracce della sofferenza e dell’oppressione è un modo per cancellare la storia e quindi anche il ricordo di quel dolore. Volerlo cancellare dal linguaggio significa volerlo cancellare dal pensiero, al modo della neo-lingua di Orwell, in base alla semplificata teoria che il linguaggio “influenzi” il pensiero.
No, non è politica. Gli animalisti, gli antispecisti e i vegani oggi sono semplicemente dei vegetariani un po’ più “radicali” ma che scambiano la propria protesta morale individuale per un atto politico. I vegetariani sono i rappresentanti millenari di un rifiuto individuale dell’uccisione degli animali che, a partire dalla nascita nell’età moderna di società per la “protezione degli animali”, si sono organizzati come movimenti di opinione (“single issue”, cioè a base monotematica). Oggi questi movimenti di individui si sono estremizzati, hanno cercato di rendere più coerenti in teoria (antispecisti) e in pratica (vegani) le proprie istanze ma senza modificarne l’oggetto che è una semplice richiesta di trattamenti migliori per gli animali non-umani, senza alcuna analisi sociale e storica del loro sfruttamento, del rapporto tra questo e la società umana nel suo complesso, limitandosi a denunciare la “cattiveria” (morale) degli altri umani. Oggi, essi sembrano scoprire che una società senza sfruttamento animale deve essere necessariamente una società diversa, ma questa consapevolezza non è riuscita a concretizzarsi in una teoria ed una prassi adeguate alla trasformazione sociale necessaria, cioè non riesce a farsi propriamente “politica”. Nemmeno in coloro (come alcuni sostenitori della vegefobia) che hanno idee politiche (anarchiche o generalmente di sinistra) ma che non sanno come mettere insieme queste idee con la richiesta di cambiamento nel modo in cui trattiamo gli animali. E di questo ho scritto abbondantemente negli articoli citati sopra in nota.
non ho scritto questo anche se non ci vedo nulla di male. “Politico” è solo l’atto che riesce a costruire una strategia di lungo periodo di trasformazione sociale, che è in grado di uscire dall’immediatezza e farsi articolazione, mediazione (non compromesso), sintesi di momenti e interessi anche non immediatamente legati alla liberazione animale ma che ne costituiscono una premessa indispensabile (rapporto con altri movimenti, problema della gestione dell’economia, problema dell’informazione, della rappresentanza politica ecc.).
Se difesa degli animali implica che l’uomo non è un animale, beh sì storco il naso.
In una nota ho fatto esplicito riferimento ad un testo in cui ho trattato questo problema con maggiore cura di quanto ci si possa permettere in un blog. Inoltre, il riferimento teorico di questo scritto è evidentemente la teoria della civiltà della Scuola di Francoforte in cui i concetti psiconalitici sono approfonditi e calibrati per darne una lettura non “pessimista” (Freud), bensì “libertaria” (a partire dai primi scritti di Fromm, alle grande sintesi de “L’autorità e la famiglia” e della “Personalità autoritaria”, nonché gli scritti di Marcuse e di Adorno su psicoanalisi e sociologia) e in cui è centrale il rapporto dialettico tra ragione e natura.
Anzitutto non mi risulta che Singer interpreti il nostro rapporto con gli altri animali in questo modo e comunque non è a Singer che faccio riferimento parlando di teriofobia, bensì agli autori sopra citati.
In secondo luogo qui si fa confusione tra “violenza” e “dominio” concetti che ho accuratamente distinto in altri miei scritti e la cui distinzione ho dato qui, erroneamente, per scontato. E questa è senz’altro una pecca del presente scritto che mi è stata fatta notare anche da altri. Ad ogni modo, è anche vero che qui io non parlo del rapporto “in generale” dell’uomo con la natura, ma dello specifico rapprorto che nella civiltà si stabilisce tra noi e la natura (interna ed esterna). Con questo intendo quindi ciò che Lévi-Strauss chiama la differenza tra società “fredde” e società “calde” (o “neolitiche”) dove la natura diventa elemento manipolabile perché gerarchicamente sottomesso all’umano (che a sua volta abbandona il tendenziale egualitarismo delle società di caccia-raccolta per istituire rapporti di classe in senso stretto).
In terzo luogo, nessuno nega che gli umani abbiano anche rapporti di ascolto e cura nei confronti degli altri animali ma sicuramente non in modo generalizzato. L’empatia è un fenomeno individuale che nella civiltà viene gestito in modo da escludere in modo potente la solidarietà con la natura, proprio perché la natura costituisce il “propellente” dell’espansione tecnica ed economica tipica dei sistemi sociali complessi e gerarchizzati. Il disprezzo di cui parlo (esattamente come l’empatia) è un costrutto sociale, non “naturale” ed esattamente per questo mi interessa ed esattamente per questo è un fenomeno politico.
Io provo a difendere Maurizi radicalizzando la sua prospettiva: Phòbos, nella mitologia Greca, era un sodale di Ares (non mi ricordo se e come imparentato, mi perdonino i filologi) che si, per così dire, “occupava”, di seminare lo Spavento per i campi di battaglia. Phòbos, perciò, non è una paura fra le altre, ma lo Spavento che minaccia direttamente la nostra incolumità, in uno spazio militare. In questo senso si potrebbe riproporre il concetto di Terio-Fobia (ma anche, perché no? tutti quegli atteggiamenti di odio – Odio, non semplice Paura – per l’altro da sé denunciati dai termini composti, un po’ consunti, che usiamo per indicare la discriminazione e la persecuzione degli “altri”: xenofobia, omofobia, ecc…) come Spavento non “subìto” da un soggetto innocentemente spaesato dall’incontro con l’altro, ma lo Spavento che tale soggetto, in una manovra di chiusura su di sé dell’identità, scatena “contro” quello. Terio-Fobia e Xeno-Fobia potrebbero allora indicare il minacciare l’altro spaventandolo, in uno spazio di guerra non importa se combattuta con le armi o con quelle “armi” della socialità che sono l’emarginazione, la stigmatizzazione, ecc… e che di solito preparano guerre, o atti di guerra, veri e propri (quindi la guerra come “igiene del mondo”, ma anche pogrom, assalti, ghettizzazioni, deportazioni e sterminii di vario tipo: addomesticamenti forzati, sterilizzazioni, abbattimenti e massacri vari di animali, aggiungiamo noi).
Pensare Phòbos anche in questa maniera, in questa direzione “inversa”, aiuterebbe anche a strappare l’idea che le fobie che accompagnano xeno-, omo-, e terio-, non sono AFFATTO naturali, iscritte in leggi di natura o in strutture culturali ricorrenti, ma mosse politiche di difesa di privilegi esclusivi inerenti una comunità.
E’ perfino ovvio, ma al giorno d’oggi è bene ripeterlo: l’incontro con l’altro da sé – o ciò/chi ci appare tale inizialmente – non implica in nessuno modo che la prima reazione debba essere di Paura, Spavento e Minaccia. Non fido molto sulla psicanalisi, perciò mi limiterò a dire che tali sentimenti – o la necessità che tali sentimenti siano iniziali e prevalenti – sono effetto di una manipolazione politica dell’ – idea di – identità e appartenenza. Gli incontri fra “razze”, culture, specie, gruppi e singoli, possono avvenire – storicamente sono avvenuti anche – nella maniera dell’ospitalità, dell’accoglienza, della curiosità e dell’ibridazione (con questo non voglio dire che tali maniere non siano tonalizzate, anche se non per lo più, da un senso di “straniamento”: ci mancherebbe). Il training dell’incontro con l’altro dominato dalla Paura che l’Occidente impone ai propri sudditi, è una manipolazione emotiva dell’identità e dell’appartenenza esercitata su scala macro e storica: dicendo che ogni qual volta esso si è incontrato con l’altro, qualcuno è finito male per una legge “naturale”, è il più cinico e astuto dei tranelli che l’Occidente ha inventato per sé stesso e per il pianeta intero
Reblogged this on Cristiana Cervelloni.
Invece descrivere chi si nutre assecondando l’istinto naturale come un mostro mangiacadaveri non è fobia, mettendo da una parte i buoni e dall’altra i cattivi. Oltre a pagine facebook come “vegano stammi lontano” ci sono “carnivoro ritardato”, inutile fare i vittimisti.
La realtà è che ad una persona onnivora non interessa affatto cosa mangia o non mangia un veg* mentre questo non è vero per un veg* per motivi etici, che vuol mettere bocca nella sfera privata degli altri come i fanatici religiosi. Non nego che non ci siano antispecisti che si fanno i cavoli loro ma sono una minoranza essendo l’antispecismo inteso come una missione.
Volete conoscere la vera dicriminazione? Provate a chiedere l’autorizzazione a piazzare manifesti con la frase “la cattiva notizia è che dio non esiste, la buona è che non ne hai bisogno” in diverse città italiane è stato vietato, in altre prima permesso poi sono sono stati rimossi con sentenza, in barba alla libertà d’espressione: puoi dire dio ti ama, ma non negarne l’esistenza.
Non mi risulta accada lo stesso per volantini veg*. In diverse parti del mondo si uccidono gli atei per il semplice motivo che sono quel che sono. Senza contare tutte le discriminazioni subite da minoranze etniche e sessuali. Non insultate il genere umano con la vegefobia.
Caro Francesco S. è un vero peccato che tu commenti gli articoli senza leggerli o leggendoli di corsa. Le conclusioni di questo articolo sono CONTRO la vegefobia. I tuoi commenti critici indirizzali al sito it.vegephobia.info, grazie!
Non mi riferivo all’articolo ma ai commenti di altri utenti, non mi sembra di aver citato l’autore.
Risposta tardiva di un anno, ma simbolica
Il problema è che il mangiare animali non è una questione privata, visto che tra te e l’animalista scocciatore c’è un terzo che ci rimette: l’animale, appunto.
Non si tratta di non mettere bocca nella fede personale o nel tifo calcistico: qui c’è qualcuno che muore davvero.
Cerca di rispettare la sfera privata degli animali.
La sfera privata dell’animale, questa me la segno. Si vada a fare questo discorso all’orso che non rispetta la sfera privata del salmone. Che cambia tra orso e homo sapiens, sono entrambi mammiferi onnivori.
L’orso non può scegliere il menù, tu sì.